L’inganno del biotestamento

di Francesco Ognibene.
Se anche ritenessimo che possa bastarci quel che già abbiamo visto, sentito e letto sin qui sul biotestamento e la relativa legge appena approvata, s’incarica poi la realtà a richiamarci a restare vigili. Perché le «Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni anticipate di trattamento» (o Dat) varate a grande maggioranza alla Camera il 20 aprile dello scorso anno e al Senato in via definitiva il successivo 14 dicembre non si limitano a introdurre alcune rilevanti novità nel nostro ordinamento giuridico sulla relazione di cura ma cambiano in modo radicale il paradigma di riferimento dell’intero sistema legislativo e sanitario sulla vita umana. Esageriamo? Nient’affatto.
Basti pensare alla distanza che passa tra la legge 38 sulle cure palliative e la 2.801 sulle Dat. La prima fu approvata nel 2010 e poi presa a modello da altri Paesi per il suo stampo profondamente umanistico in un’era di dominio della tecnologia, eppure in Italia resta ancora largamente inapplicata. Al centro di quella legge c’è la dignità del paziente al quale va garantito il diritto di affrontare l’ultimo tratto della vita con la piena «tutela della dignità e dell’autonomia», oltre alla «promozione della qualità della vita fino al suo termine» e l’«adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale» a lui e alla famiglia. La legge 38 dispone che ci si prenda cura dell’altro, perché è consapevole che di questo la persona umana ha bisogno. Un approccio saggio che ascolta le vere necessità del paziente ritenendolo anzitutto una persona ancora e sempre nella sua pienezza. Nel testo varato sette anni fa (ma che la stragrande maggioranza degli italiani non conoscono) si coglie la sapienza della cultura cristiana di un Paese – e di una civiltà – che alla figura del buon Samaritano vede ispirarsi innumerevoli testimonianze personali e sociali del sapersi far carico della sofferenza altrui, e dispone che mai si possa recedere dalla coerenza rispetto a questo stile.
Non altrettanto si può dire purtroppo della ben più reclamizzata legge sul fine vita, che rovescia il fondamento sul quale si costruisce l’impianto normativo: con le Dat lo Stato prende atto che si possa chiedere e si debba ottenere di interrompere la propria vita quando si ritiene venuta meno la propria dignità, senza neppure fissare criteri temporali (ad esempio, la terminalità della malattia) o clinici (la refrattarietà alle cure, o l’accertata mancanza di margini per un miglioramento). In pratica al diritto di essere assistiti si sostituisce – senza neppure dirlo – quello di morire quando e come si desidera. Basta chiedere, lasciandolo scritto nelle proprie disposizioni (e non semplici dichiarazioni) anticipate di trattamento, e nessun medico potrà opporsi.
È la conferma di come spesso nel nostro Paese le leggi servano assai più come grimaldelli per introdurre nuove letture della realtà, e dunque diffondere una mentalità e una cultura calate dall’alto, che come strumenti per risolvere problemi: leggi come quella sulle Dat si configurano, in altre parole, come “manifesti”. Era necessaria una legge per affermare il diritto di rifiutare le terapie, sospendere le cure o evitare l’accanimento terapeutico? O la Costituzione, la deontologia medica e il rapporto personale tra ogni medico e ogni paziente già bastava come garanzia per evitare situazioni che potessero ledere la dignità del paziente? E ha senso una legge per sua stessa natura generalista per regolare ognuna delle infinite situazioni concrete nelle quali si incarna un percorso di fine vita? Come ha osservato più di un medico, scettico oltre che preoccupato per un’ulteriore dose di burocratizzazione aggiunta alla vita professionale, delle Dat non si sentiva alcuna mancanza. Tanto più che una legge sul fine vita il nostro Paese già l’aveva: quella sulle cure palliative, appunto, e per di più esemplare e impegnativa. Ma evidentemente andava affermato un nuovo principio, facendo leva sulla retorica ormai inarrestabile dei “nuovi diritti” e della libertà individuale eretta a dogma illusorio di una società dove si convincono i cittadini di poter fare di sé ciò che meglio credono, quasi a voler eludere un discorso serio sulle vere libertà e i veri diritti che oggi reclamano di essere ascoltati (primo tra tutti quello di essere curati e assistiti come la propria malattia esige), e forse sul diritto e la libertà in quanto tali.
Il rovesciamento del metro col quale si misura la vita umana è un passo grave al quale ci si è disposti in una situazione paradossale se si pensa alla posta in gioco: è noto infatti che con pochi giorni di lavori parlamentari ancora a disposizione prima dello scioglimento delle Camere una maggioranza trasversale e anomala che va dal Pd a M5S alle varie formazioni della sinistra radicale, pescando però anche in altri partiti, ha scelto il fine vita come scalpo da esibire ai potenziali elettori lasciando scadere un gran numero di altri provvedimenti assai più rilevanti. Il senso politico di una simile operazione sfugge, a meno che non si ascolti l’esultanza di chi questa legge l’ha ispirata davvero avendo in mente una chiara strategia per giungere per via parlamentare o giudiziaria (i prevedibili contenziosi per applicare una norma confusa e ambigua) alla legalizzazione dell’eutanasia e del suicidio assistito, senza obiezione di coscienza.
Se la si vede sotto questa lente, la legge sulle Dat appare dunque come un altro passo verso la secolarizzazione del Paese ripulito con metodicità da ogni residuo di “principio primo” che superi e preceda la volontà individuale eretta a nuovo idolo, e da ciò che può fondarlo, legittimarlo e renderlo condiviso, religione in primis. Più che una legge, un’altra mano di bianco stesa sul capolavoro dell’umanesimo che ispira la nostra comunità nazionale. Di solito, l’ideologicità di operazioni simili non fa i conti con la resistenza della realtà e dell’essere umano rispetto a operazioni che ne forzano la natura. Ora tocca anche a ciascuno di noi testimoniare che non c’è diritto di morire che valga la vita.

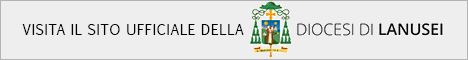







.png)



Lascia un Commento