Dalla Sardegna all’Antartico per studiare il clima

di Fabiana Carta.
Mario Lecca, 40 anni, di Austis, fisico meteorologo dell’Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure), ha fatto parte del gruppo composto da 13 persone durante la spedizione scientifica DC20, nella stazione italo-francese Concordia, sull’Altopiano Antartico
È terminata la DC20, la 39esima spedizione scientifica italiana in Antartide: il tuo compito era seguire alcuni progetti di ricerca nel campo della meteorologia e fisica dell’atmosfera. Quali risultati e scoperte hai portato a casa?
La base Concordia, che ha compiuto 20 anni proprio l’anno scorso, è una base scientifica ed è nata come supporto a uno dei più grandi esperimenti sul clima chiamato Epica che è arrivato a stimare il clima di 800mila anni fa, arrivando a una profondità di 2480 metri. Nel corso degli anni sono nati altri esperimenti in vari ambiti scientifici, dalla fisica dell’atmosfera alla meteorologia, sismologia, magnetismo, astrofisica e glaciologia. I miei ambiti di studio hanno riguardato la meteorologia con un osservatorio meteo permanente, lo studio della radiazione solare, studio di nubi e precipitazioni e del particolato atmosferico. L’analisi dei dati raccolti ha sempre un po’ di ritardo rispetto alle acquisizioni, tutti i campioni e i dati mandati in Italia e in Europa saranno analizzati nei prossimi mesi.
13 mesi nel cuore dell’Antartide, di cui 9 in completo isolamento perché nessuno avrebbe potuto raggiungere la base Concordia, a circa 4000 metri di altitudine e a -80 gradi centigradi, in un ambiente di aria secca carente di ossigeno. Come ci si prepara per una missione così estrema?
Gran parte della preparazione avviene dal punto di vista psicologico perché riprodurre quelle condizioni è pressoché impossibile. Ma anche la selezione dal punto di vista fisico è molto rigida, l’idoneità si ottiene dopo aver superato una serie di test psico-fisici presso l’ospedale militare di Roma, analoghe a quelle a cui si sottopongono i piloti dell’aeronautica militare: bisogna godere di ottima salute e in questo mi ritengo molto fortunato. La formazione prevede una settimana di permanenza sul Monte Bianco con la supervisione di guide alpine dell’esercito, più altre due settimane: una di formazione tecnica e una in cui, in presenza di due psicologi, si studiano le dinamiche di gruppo e si può venire esclusi in qualsiasi momento. La motivazione è importantissima per resistere a un periodo così lungo di isolamento e condizioni estreme.
La missione è stata anche una sfida sociale. Com’è stata la coesistenza forzata con un gruppo di persone che non conoscevi?
La missione è stata soprattutto una sfida sociale. Condividere spazi ristretti con persone sconosciute è complicato, è stato un continuo esercizio di pazienza e tolleranza, anche un piccolo problema può essere amplificato. È molto importante la gestione dei conflitti: è impossibile evitarli, ma bisogna puntare alla risoluzione perché la reazione personale all’isolamento o ai 4 mesi di buio è molto soggettiva. Bisogna ricordarsi in ogni momento di far parte di una squadra in cui magari c’è qualcuno che ha più bisogno di aiuto. Posso dire che questo aspetto mi ha arricchito moltissimo e che mi sono fatto anche qualche amico. In queste condizioni anche l’intensità dei rapporti è amplificata.
Intorno a te, a parte i tuoi compagni di missione, nessuna forma di vita. Come hai vissuto la solitudine? Quali sono state le difficoltà maggiori, da questo punto di vista?
L’unicità di questa esperienza consiste anche nello stacco dalla routine e dai ritmi veloci della nostra società, cosa che ho imparato ad apprezzare avendo a disposizione più tempo per me stesso. Per me è stata molto importante la lettura e l’attività fisica. Ho letto tantissimi libri e l’attività fisica era un momento di sfogo: assieme al sollevamento pesi che è stata una necessità, vista la mia perdita di peso, ho praticato yoga e meditazione. Ho persino iniziato a suonare la batteria prendendo lezioni in videoconferenza dall’Italia. Insomma, mi sono goduto la solitudine, ma ho anche preso consapevolezza che per me la condivisione è importante e non potrei fare una vita da eremita. Ci sono stati momenti in cui vedere una persona cara in videochiamata poteva essere importante quanto il cibo. In base non mancavano comunque i momenti di socialità e condivisione.
Dopo questa esperienza è cambiato il tuo rapporto con la natura, la vita?
Sono cambiate molte cose. Di fronte alla grandezza della natura, per quanto inospitale e avara in questa zona della terra, ci si sente molto piccoli e impotenti. Il mio rapporto con la natura era già di estremo rispetto, avendo fatto sport acquatici e andando in montagna, ma in condizioni così estreme devi sviluppare un’attenzione particolare. Uscire all’esterno con -80 °C è molto rischioso e niente può essere lasciato al caso, una minima distrazione può essere fatale. Di contro, uscire a mezzogiorno con una Via Lattea così luminosa che sarà difficile rivedere, stare attaccati alla finestra ed essere pronti a uscire a qualsiasi ora per ammirare l’aurora è un’emozione unica. Questo luogo inospitale può sembrare noioso e monotono ai più, ma regala tante piccole sfumature diverse ogni giorno, nei paesaggi e nei colori, per chi impara a osservarle.
Sei tornato una persona diversa? L’unicità di questa esperienza ti ha dato delle risposte a livello spirituale, personale?
Mi porto dietro un bagaglio di esperienze unico, soprattutto a livello personale, e qualche cambiamento c’è stato, anche se ancora è presto per fare un bilancio complessivo. È stato sicuramente un anno di riflessioni scaturite da un profondo contatto con sé stessi, un viaggio nelle zone più profonde del proprio animo che a volte non abbiamo il coraggio di esplorare. In queste condizioni si fanno un po’ i conti con ciò che si è davvero, ci si mette alla prova e si affrontano anche i propri difetti. Ho rivalutato l’importanza del tempo, di azioni semplici della vita quotidiana che diamo per scontate, ma che non lo sono e di cui in queste condizioni si sente la mancanza. Si rivaluta l’importanza delle relazioni e del calore umano.
Ora che sei tornato, ti manca qualcosa dell’Antartide e di quella esperienza? È difficile riadattarsi alla vita “normale”?
A circa un mese dal rientro, il riadattamento è una parte altrettanto difficile. Si passa da avere pochi stimoli alla sovra stimolazione della vita a cui pensiamo di essere abituati e questo, assieme ai ritmi lavorativi completamente diversi, può essere causa di stress. Molto banalmente, al rientro si è molto sensibili ai rumori (ho evitato per un po’ posti troppo affollati) e persino ai colori, dal momento che per un anno non ho sperimentato una grande varietà cromatica.
È stato particolarmente emozionante ritrovarsi immersi nella vegetazione primaverile della Nuova Zelanda nella via del ritorno. Ancora ho qualche difficoltà nel rivedere le foto scattate in Antartide perché sono ancora vive le emozioni che richiamano. Qualcuno parla di “mal d’ Antartide”, simile al “mal d’Africa”, e nel mio caso sento un po’ di nostalgia della vita in base, dei luoghi tanto inospitali quanto affascinanti e della particolare condizione che si sperimenta, sapendo di far parte di un ridottissimo numero di persone che hanno avuto la fortuna di poter vivere in questo continente.

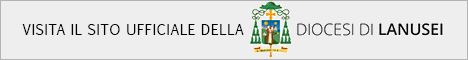

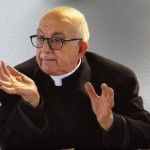





.png)


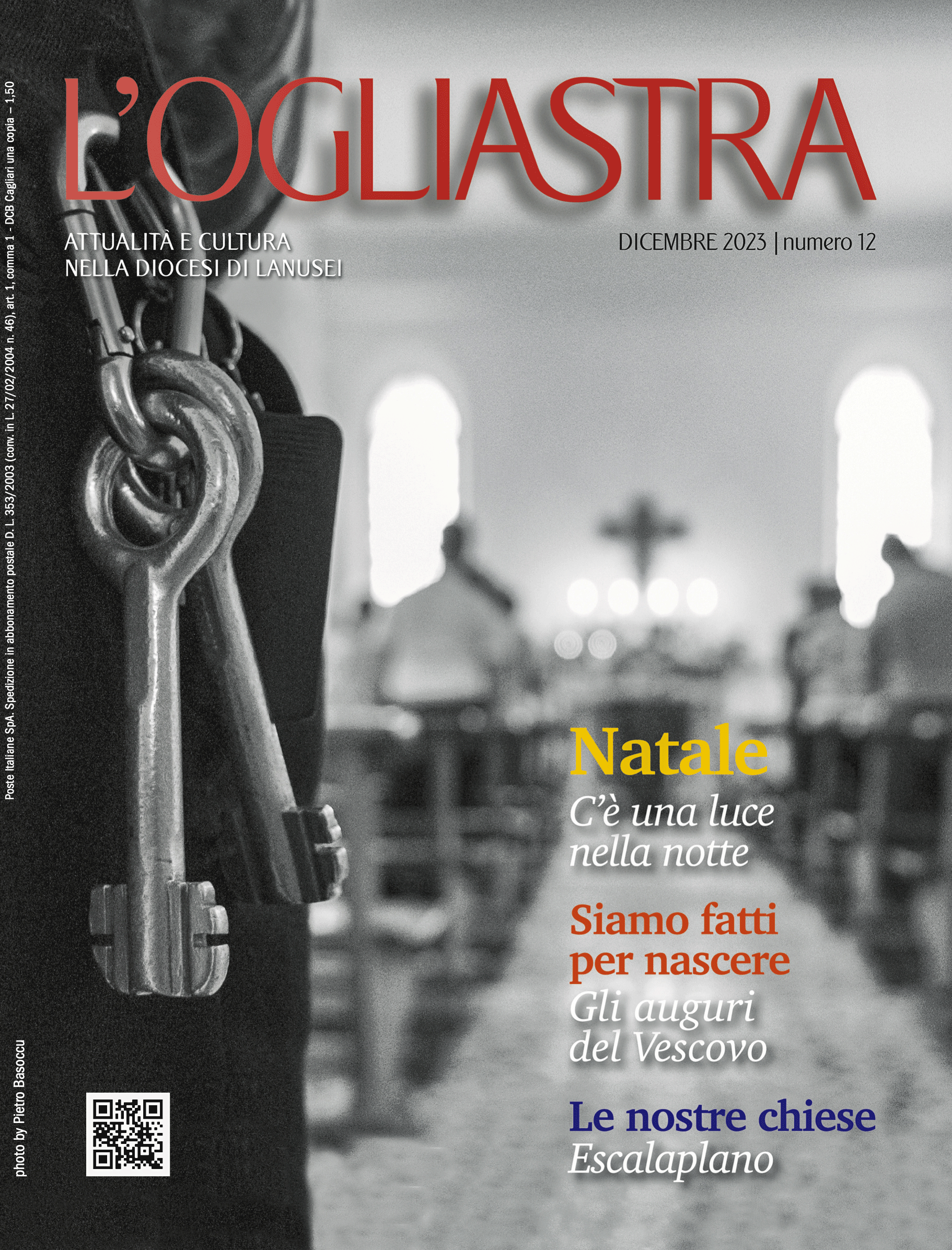
Lascia un Commento