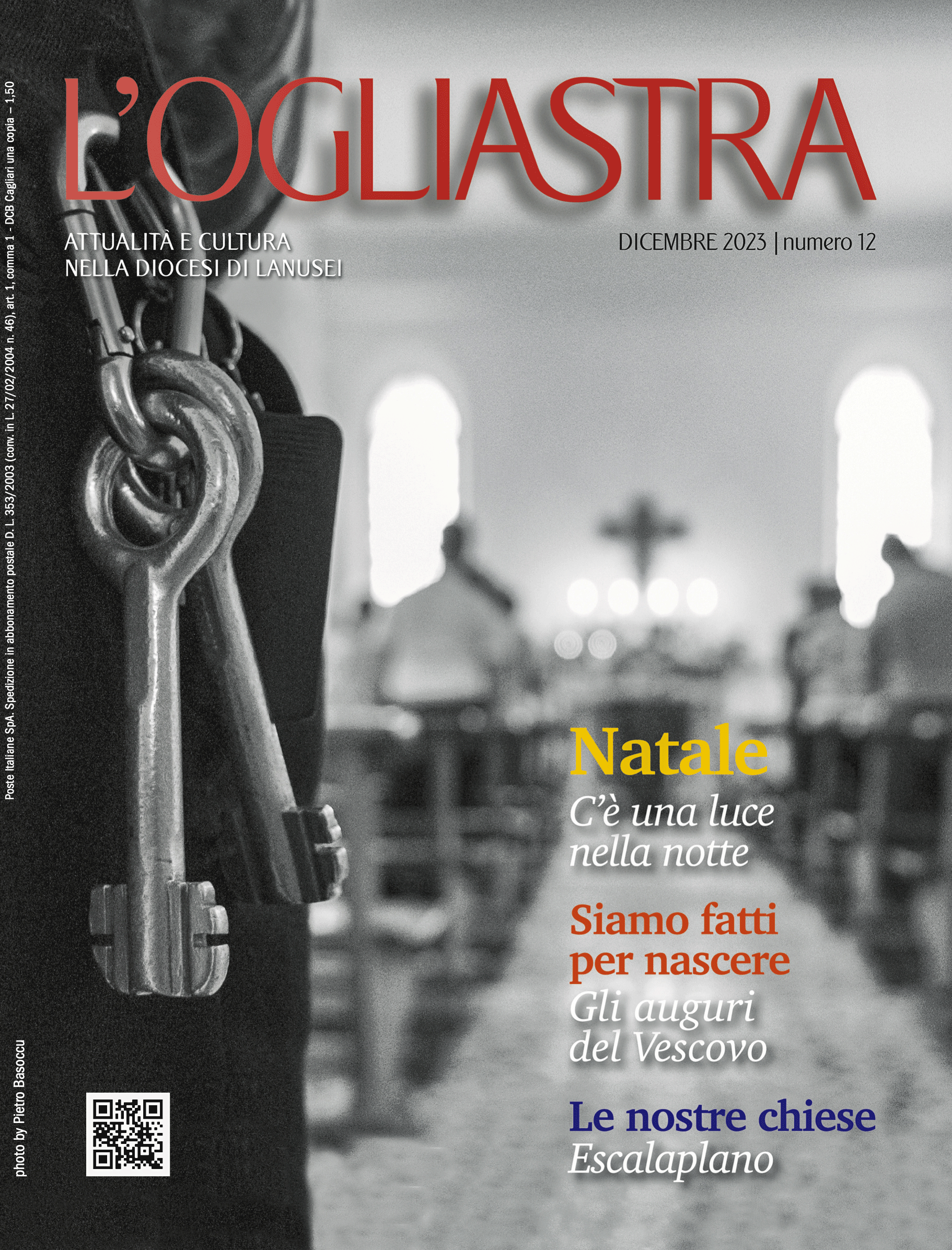Volti e persone

Antonio Conigiu. La perennità sulla pelle
di Alessandra Secci.
Si fa presto a chiamarlo tatuatore.
La passione che muove Antonio Conigiu, villagrandese doc di stanza ad Ardea, è così recondita che non si può che parlare di arte. È l’arte, infatti, ad animarlo, ben prima di diplomarsi come geometra, alla fine degli Anni Ottanta, a Nettuno: l’evoluzione della professione è stata pazzesca, nonostante ancora oggi resistano, dopo tanto tempo, sacche pregiudiziali difficili da estirpare. Ma il percorso di quest’arte – così affascinante eppure bistrattata, incompresa –, della sua “emancipazione” sociale, e quello personale e professionale di Antonio, si intrecciano inesorabilmente.
Pioneristica.
«Mi dedico all’arte a 360° sin da ragazzino – racconta – la pittura ad olio, che di recente ho messo da parte, mi affascina da anni, ma preferisco tenere questa e la mia attività lavorativa separate, pur essendo due forme d’arte. È stato difficile perseverare nel proposito di continuare su questa strada, sono partito verso il continente nel 1987, subito dopo il servizio militare; a Tortolì ho collaborato, quasi “a bottega” da Claudio Zaini, milanese trapiantato in Ogliastra. Nel 1995 ho aperto lo studio a Tor San Lorenzo, con milioni di difficoltà, a partire da quelle di carattere tecnico: l’attrezzatura era ridotta all’osso, gli aghi erano sfusi, andavano saldati, controllati e sterilizzati. Spesso le domeniche erano interamente dedicate a questo passaggio, rognosissimo, che però mi consentiva di stare tranquillo durante tutta la settimana; anche le macchinette e i pigmenti erano “autoprodotti”, pure perché non vi era una rete di distribuzione come quella odierna. La Svolta del ’98, come la chiamo io – (con l’avvento cioè delle circolari ministeriali del 5 febbraio e del 16 luglio, nelle quali si chiarirono per la prima volta le linee guida da tenere per eseguire i tatuaggi e i piercing in condizioni di sicurezza, ndr) – ha dotato la categoria di un minimo di inquadramento, collocandoci negli artigiani, garantito la tutela di cui avevamo bisogno e dato finalmente quella dignità professionale che è sempre mancata. Anche se è questo è il risvolto felice della storia».
Il lato romantico.
«Il rovescio della medaglia – prosegue – è l’eccessivo sdoganamento che la professione ha subìto. Se da un lato, infatti, quella certa aurea pregiudiziale che avvolgeva anche noi operatori – spesso messi alla stessa stregua dei delinquenti nostri committenti, gli unici che potevano permettersi (economicamente ma non solo) il tatuaggio – è progressivamente svanita, lasciando fortunatamente spazio, come detto poc’anzi, alla rivalutazione morale della professione e a un dignitoso incasellamento lavorativo, dall’altro, in breve, si è assistito all’inesorabile perdita di quella magia, quel misticismo da cui il tatuaggio e l’atto del tatuare erano composti. All’attività si avvicinavano sempre più persone, ma con poca dimestichezza e ancora meno passione: la Regione Lazio istituì persino dei corsi di brevissima durata (90 ore) in cui si impartivano i primi rudimenti della professione, ma è chiaro che un lasso di tempo così risicato non può competere in un settore nel quale l’esperienza pluriennale è ciò che fa la differenza, ed è anche raro che si presenti la possibilità di andare a bottega, cioè di poter imparare pazientemente il mestiere presso altre realtà. Altra nota dolente, sul versante della rappresentazione pura: inorridisco nel vedere strafalcioni su pelle, che non tengono conto della giusta composizione e dinamicità che un lavoro deve avere. Rappresentare, ad esempio, una peonia e un crisantemo insieme, in una struttura narrativa che segue l’andamento ciclico del tempo e delle stagioni, significa snaturare il tutto, e questo non è mai un bene. E Internet, da questo punto di vista, non è certamente stato d’aiuto, anzi: quei codici di cui sopra sono stati travisati, mescolati, confusi. E si è praticamente perduta l’essenza di un’arte antica (in Giappone e altri contesti è una tradizione plurisecolare) che invece merita maggiore attenzione e serietà di esecuzione».
Ragione e pentimento.
«Qualunque esse siano, le immagini rappresentate – prosegue Antonio – rivestono un’importanza fondamentale anche per il loro carattere peculiare: la loro perennità. Un quadro, una tela, un muro bianco sono reversibili, l’epidermide no. Io stesso possiedo ancora traccia dei miei primi tatuaggi, orrendi, malfatti, scoloriti: ma sono io, è la mia storia, e anche se li includo in altri più grandi e marcati, restano, a ricordarmi chi sono. In tanti propendono per la cancellazione con diverse tecniche, tra cui il laser: anche questa, una diretta conseguenza di quelle leggerezza e scarsità di contenuti a cui si faceva cenno. Così all’eternità si innesta (e a volte si sostituisce) la temporaneità. Ed è un peccato: il tatuaggio non è per i pentiti».

Un buon caffè sotto la Mole con Alessandra e Gabriele
di Elisabetta Cadeddu.
Se c’è scritto “Caffè Sardegna”, è sicuramente quello di Alessandra e Gabriele. Da Seulo con amore
Non è semplice lasciare la propria famiglia per andare a cercare un futuro migliore, ma Alessandra Agus penultima di sette figli, sa bene cosa significhi. Lascia la sua casa di Seulo nel 2000, poco più che maggiorenne, per raggiungere una delle sorelle più grandi a Cagliari, iniziando così a costruire sogni e progetti lontano dal caldo e sicuro nido familiare.
Lavoratrice instancabile, nello stesso anno incontra Gianluigi. Dall’amore dei due genitori, presto arrivano Sara e Daniele. Ma, come tutte le storie d’amore, un capitolo triste si apre e Alessandra, non ancora trentenne, in una fredda giornata del febbraio 2010, perde il suo sposo a seguito di un incidente motociclistico. Tenace e caparbia come tutte le donne – e come tutte le donne sarde –, supera lo shock iniziale. Il cuore è a pezzi, ma decide di tornare tra i suoi monti e riprendere da qui la sua vita; trova occupazione presso la casa di un anziano e, con l’amore che da sempre la contraddistingue, si dedica alle sue cure. Anche Sara e Daniele si immergono nella vita seulese e subito si iscrivono al catechismo esprimendo il desiderio di entrare nell’ACR.
Il tempo passa e Alessandra matura nel suo cuore un desiderio di nuova rinascita, di un futuro migliore per sé e per i suoi bambini. Grazie a Gabriele, un caro amico di gioventù, a febbraio del 2014 trova un impiego e, affidando i bambini alle cure di sua madre e delle sue sorelle, prepara la valigia: destinazione Torino. I piccoli, però, non possono né vogliono stare lontano dalla loro mamma. Così, nel giro di poco tempo la famiglia è nuovamente riunita all’ombra della Mole Antonelliana.
L’amicizia con Gabriele presto si trasforma in amore e a ottobre i due diventano marito e moglie. Nel 2016 Alessandra prende da sola in gestione il Circolo dei Sardi dove, quando può le da una mano suo marito. Trascorrono tre anni e i due si rendono conto che vogliono qualcosa di più, qualcosa che sia tutta loro. Nel gennaio 2020 acquistano un bar a Torino la cui inaugurazione avrà luogo il 24 febbraio. Ma un’altra nuvola arriva a oscurare il cammino di Alessandra: il Covid19. Il 5 marzo, lei e Gabriele, come la maggior parte dei proprietari di attività analoghe e come tutta l’Italia, si fermano, costretti ad abbassare le serrande a causa del lockdown, e con bollette e mutui comunque da pagare.
Stavolta, però, non è sola: l’amore di suo marito e dei suoi bambini alimenta la fiamma della speranza e, non senza pochi sacrifici, tengono duro fino alla prima parziale riapertura di maggio, prima con il servizio d’asporto per poi tornare pian piano alla normalità, situazione che a tutt’oggi non si può dire certo di aver riacquistato. «Che dire – sostiene l’imprenditrice di Seulo – la vita è così, bisogna farsi coraggio e cercare sempre la luce anche dove luce non c’è, riprendere a sorridere anche quando tutto sembra perduto perché niente è perduto se c’è l’amore».
Come a dire – e questo è il suo grande insegnamento – che in ogni cielo passeranno le nuvole a oscurare il sole, ma se sotto soffia il vento dell’amore, ogni nuvola potrà essere spazzata via e il sole potrà brillare ancora sulla vite di ciascuno.

Nicola Monni e la passione del biologico
di Debora Asoni.
Arzana. Alle pendici del monte Idolo un meleto biologico nato durante la pandemia. A realizzarlo, Nicola Monni, imprenditore agricolo, classe 1993.
Ragazzo dalle idee chiare Nicola Monni, ventotto anni, arzanese. Dopo il diploma, il lavoro nel settore edile come da tradizione familiare e il desiderio di creare qualcosa di innovativo che abbia a che fare con la terra delle sue origini.
L’occasione si presenta sotto forma di chiacchierata con un amico che gli parla delle colture biologiche. Da lì la decisione di effettuare i corsi e conseguire gli attestati per ottenere la declaratoria di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), la ricerca del terreno e la trafila burocratica per accedere ai finanziamenti regionali destinati ai nuovi insediamenti agricoli.
L’anno scorso, durante la chiusura dovuta alla pandemia, Nicola procedeva finalmente alla costituzione del meleto: un impianto agricolo composto da oltre un migliaio di piante, disteso su una superficie di circa un ettaro nella collina di San Giovanni che dai piedi dell’abitato guarda direttamente al mare della costa orientale.
Mele completamente biologiche: dalla Golden alla Fuxi, alla Royal Gala, Red delicious e Granny Smith a cui si dedica a tempo pieno con cura e dedizione in modo da ridurre ancora di più i trattamenti da eseguire e preservare il frutto, mantenendolo il più naturale possibile.
La passione per l’agricoltura nel corso di quest’anno è cresciuta, tanto che per Nicola l’attività è diventata a tempo pieno. Il lavoro nel settore agricolo è fatto di cicli con diversa intensità di impegno: fasi molto impegnative subito prima della raccolta e durante la raccolta stessa si alternano a periodi morti, fatti di attesa e rispetto della terra. L’impianto è, adesso, in produzione e lui ha potuto lasciare definitivamente il precedente lavoro, non escludendo di potersi dedicare ad altre colture frutticole nel prossimo futuro.
Le coltivazioni agricole, anche quelle biologiche, hanno bisogno di numerosissimi trattamenti atti a proteggere il frutto dai parassiti che possono danneggiarlo, ma fortunatamente il clima mediterraneo tipico delle nostre terre insieme all’ottima esposizione solare, i venti e la salubrità dell’aria, proteggono essi stessi le coltivazioni, facendo in modo che i trattamenti siano ridotti al minimo – solo qualcuno per la precisione – mentre in altre zone della nostra penisola, come ad esempio al nord Italia, seppure rinomato per le produzioni di mele, il clima meno generoso impone un carico di lavoro maggiore per gli agricoltori e un sacrificio ulteriore per le piante che vengono costantemente sottoposte a processi di protezione. Ciò significa che le mele coltivate nei nostri territori presentano proprietà organolettiche e una qualità ancora maggiori.
Mi racconta che è stato bello potersi interfacciare con aziende e agenti economici del settore, anche di altre regioni, contribuire alla produzione e alla distribuzione del bene e quindi introdursi nella filiera agroalimentare come nuovo giovane attore: «Il piacere di dedicarsi a questo settore – afferma – supera la fatica dei numerosi controlli a cui sono sottoposte le colture biologiche, i cui prodotti devono avere uno standard molto elevato di qualità».
Ma non nasconde anche le difficoltà: «Non è facile inserire il proprio prodotto nel mercato locale a causa della forte concorrenza dei prodotti di importazione che invadono il mercato nostrano. Se vi fossero più produzioni locali la concorrenza verrebbe facilmente superata. Ma i giovani sardi hanno maggiori difficoltà a mettersi in proprio in tutti i settori, anche in quello agricolo, a causa di uno svantaggio economico di partenza dovuto alla mancanza di capitale, per cui è necessario riferirsi alla famiglia per trovare un supporto economico di avvio della iniziativa». D’altra parte, le misure pubbliche a sostegno delle intraprese economiche danno un aiuto non immediato e richiedono l’equity, ossia una percentuale di mezzi finanziari propri.
Le nuove generazioni del nostro territorio sono spesso costrette ad abbandonare la loro terra in cerca di lavoro e di prospettive migliori per il futuro. Mi suscita grande dispiacere pensare che questo enorme capitale umano, ricco di progetti e di aspettative, debba andarsene definitivamente, vivere altrove, per non tornare più nella propria terra natia. L’impoverimento giovanile è il grande male dei nostri paesi. Per tali motivi è necessario promuovere degli interventi e dei sussidi più mirati ai bisogni dei ragazzi.
Della storia di Nicola mi ha colpito il desiderio di fare imprenditoria agricola con gli standard moderni della green economy, in cui oltre al profitto economico della produzione, si prende in considerazione l’impatto ambientale.
Un esempio virtuoso per tanti altri ragazzi alla ricerca di una occupazione, spesso offuscati dal mito del posto fisso. Una storia capace di dimostrare come si possa dare vita a una economia positiva, rispettosa dell’ambiente e capace di fare la differenza.
Le Nazioni Unite identificano nell’economia verde un sistema produttivo in grado di produrre benessere individuale ed equità sociale nel completo rispetto dell’ambiente circostante. Infatti tra gli obbiettivi principali dell’economia verde si individuano la riduzione di emissioni di CO2 e gas serra, principali responsabili di inquinamento e cambiamenti atmosferici, l’utilizzo consapevole delle risorse naturali, evitando lo sfruttamento eccessivo di fonti non rinnovabili e impiegando in misura maggiore quelle rinnovabili, la riduzione del materiale di scarto e dei rifiuti nei processi produttivi, con particolare attenzione al riciclo e al riutilizzo, la prevenzione della perdita di biodiversità e degli ecosistemi naturali e la maggiore inclusività dal punto di vista sociale.
Creare ricchezza salvaguardando l’ambiente è una sfida importante, per questo è fondamentale che settore pubblico e privato uniscano le forze pianificando azioni e politiche mirate al fine di raggiungere l’obbiettivo.

Antonio Tosciri, barbiere classe 1995
di Michela Tuligi.
Lungo la Via Orientale Sarda, al civico n. 140, in un settembre baunese ancora popolato dai turisti, spunta una nuova insegna: Tonsor 480.
480 come l’altitudine in cui ci troviamo. È la piccola bottega di Antonio Tosciri, barbiere classe 1995.
Tornano a popolarsi le vie di Baunei, traccia di una comunità che cresce con fiduciosa speranza verso il domani.
Il volto di Antonio parla assieme alle parole, parlano gli occhi quando racconta la storia di questo mestiere. Dapprima solo una passione la sua, un passatempo che coinvolgeva amici e familiari ben disposti a fare da cavie per i primi tagli. Sono proprio loro, gli affetti, le persone alle quali va il suo principale grazie, loro che sempre lo hanno incoraggiato e spronato. Quella stessa passione, praticata per anni da autodidatta, si è poi trasformata pian piano in mestiere, fino ad arrivare al diploma in accademia nel 2017. Qui la creatività si è finalmente unita alla tecnica, aggiungendo nuove competenze capaci di realizzare forme, tagli e lavori che fino ad allora stavano solo nella sua mente. Poi l’esperienza fuori dalla Sardegna, a Milano, a inseguire un sogno nella città simbolo del fashion e del design, con il cuore sempre rivolto a casa e il progetto di riportare qui le ispirazioni metropolitane.
Fino ad arrivare alla scelta di aprire bottega a Baunei: tornare e rimanere dove tutto ha avuto inizio. Gli chiedo del coraggio, quello che ci vuole per restare.
Perché vivere in un paese come Baunei è forse per certi versi complicato, è un continuo voler fuggire e fermarsi, è odio misto ad amore per questi luoghi, sempre. Per Antonio casa ha avuto sempre e solo un nome: Baunei. Non è solo una questione di radici, la sua, è consapevolezza della fortuna che ha avuto nel nascere in questo piccolo pezzetto di mondo, ad aver come amici i propri compagni di asilo, gli stessi di sempre, quelli dei primi esperimenti con le forbici, le cavie degli esordi, quelli che da sempre fanno il tifo per lui.
Ammette che forse un pizzico di coraggio ci vuole comunque, perché aprire un’attività propria è un sogno ambizioso, soprattutto in tempo di Covid, soprattutto in un settore come questo che ha sicuramente subito l’impatto negativo portato dalla pandemia. Ci ricordiamo tutti i periodi di chiusura del 2020 e i tagli fai da te che vedevamo per strada.
Ma è proprio in questo periodo decisamente sfortunato che sono iniziati i lavori che lo hanno portato a Tonsor 480.
Le difficoltà sono state tante e non nega ci sia voluto impegno, ma il lavoro duro ripaga sempre, e la soddisfazione nel veder realizzato quello che qualche anno prima era solo un sogno è sicuramente la giusta ricompensa.
Ci sono voluti mesi di preparativi, il supporto di familiari e amici, ma ogni metro quadro, ogni arredo, ogni oggetto che vedete posizionato qui dentro, lo rende orgoglioso del risultato raggiunto frutto di impegno e passione.
La crescita che Baunei ha avuto negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti, lo testimoniano le numerose serrande che piano piano riprendono a sollevarsi lungo la via Orientale Sarda, serrande che per lungo tempo, troppo, sono rimaste chiuse.
Antonio è felice di prendere parte a questa rinascita e di dare il suo piccolo, personale contributo alla ripresa del centro storico.
Investire e credere nel proprio paese è per lui l’unico modo per difendere l’economia locale, quella vera, che produce reddito e lavoro vero, fiducia nel futuro e nella possibilità di poterselo costruire nell’unico posto che sempre chiamerà casa. E quando ad Antonio si chiede di parlare dei giovani e dei loro sogni racchiusi dentro un cassetto a prendere polvere, il suo consiglio è semplicemente quello di buttarsi, o almeno provare a farlo.
Perché è solo mettendosi in gioco che si ha la possibilità di raggiungere i propri obiettivi.
La sua ricetta è semplice: serve una buona dose di coraggio, voglia di lavorare e tanta buona volontà. Serve l’anima e il cuore, quello che si mette in un nuovo progetto da realizzare. E mentre mi trovo qui, al civico 140 basta uno sguardo per capire che la cura del dettaglio Antonio la dedica a tutto quello che fa, traspare in ogni singolo oggetto perfettamente disposto dentro queste mura, nello sguardo soddisfatto di un cliente che varca la porta.
Non ero presente all’inaugurazione di Tonsor 480, ma la felicità stampata sopra il volto di Antonio riesco a immaginarla lo stesso, qui tutto profuma d’amore e attenzione, per il proprio lavoro, per la propria terra, per un sogno che prende forma.
La stessa cura che si riserva alle cose belle e buone e che mi fa sperare che a salvarci saranno proprio loro, i giovani di questo paese. Perché i paesi come Baunei hanno bisogno esattamente di ragazzi come loro. Del loro amore per questi luoghi, della loro testardaggine nel voler continuare ad abitarli. Sono loro il futuro della nostra terra, occhi nuovi e forse un po’ avventati, ma capaci ancora di guardare lontano.
Bravo Antonio! Vado via pensando che vorrei farlo anche io, non il barbiere a Baunei, nemmeno il giovane o l’imprenditore, ma avere semplicemente coraggio e inseguire i sogni.

Un cuore di cartapesta
di Fabiana Carta.
Talento musicale ogliastrino, Marco Cannas – in arte Zeep – è un ventottenne che divide la sua vita fra lo studio di registrazione e lo studio di architettura dove lavora. Due facce della stessa medaglia, due mestieri in cui è necessario creare, scovare idee e nuove ispirazioni.
Molto legato alle sue origini, mi racconta della sua infanzia trascorsa a Villagrande Strisaili e del trasferimento a Tortolì, all’età di 14 anni. La sua attitudine artistica emerge molto presto, verso i 5 anni, quando inizia a inventare canzoni e a trasformare questa attività in un gioco molto divertente: «Mi piaceva cantare, improvvisavo i testi e li memorizzavo, senza mai scriverli effettivamente. Ho riscoperto questa passione solo intorno ai 19 anni, quando ho iniziato a scrivere delle canzoni vere e proprie».
La famiglia di Marco si accorge subito dell’impegno e della passione musicale, comprende che alimentarla sarebbe stata la cosa più giusta da fare, così – quando ancora frequenta le scuole elementari – lo iscrive alla scuola civica di musica, per studiare chitarra. Oltre che la prima sostenitrice, la famiglia è stata anche il suo primo pubblico, come spesso accade. Ricorda le estati in cui organizzava dei concerti nel cortile dei suoi nonni, l’euforia e la gioia: «Costringevo i parenti ad ascoltarmi», conclude ironico.
Marco cresce e i suoi testi crescono insieme a lui. Per quanto un artista si costruisca un personaggio o decida di nascondersi in parte dietro uno pseudonimo, la sua anima viene fuori, trascinata da parole che non sono messe lì a caso. Le prime vere canzoni prendono vita all’età di 19 anni, quasi come un passatempo, in maniera molto leggera: «Ci si incontrava con gli amici in studio e si scriveva insieme senza per forza dover concretizzare il tutto», racconta.
Il suo primo lavoro, dal titolo “Bangerang”, esce nel 2016 inserendosi nel genere rap. Da allora Young Zeep, poi diventato solo Zeep, ha collezionato tante soddisfazioni e successi, passando per collaborazioni italiane – quella con En?gma fra tutte – e internazionali, come quella con Kosswan, rapper francese, e Legacy Bailey, rapper californiana.
Cosa è cambiato, nel corso del tempo? «È cambiato tutto – spiega –, sia nel processo creativo che nelle tempistiche, ma soprattutto (per fortuna) nel risultato finale. All’inizio era un passatempo e lo vivevo con molta più superficialità. Ora, avendo firmato un contratto discografico, ho sicuramente più scadenze e responsabilità, ma la voglia di divertirmi è sempre la stessa. Sto lavorando con professionisti e con artisti che fino a poco tempo fa sembravano inarrivabili e di questo vado molto fiero. Sono anche decisamente più soddisfatto delle canzoni che scrivo, perché crescono insieme a me», confessa.
Ascoltando qualche vecchio brano, e facendo il paragone con quelli più recenti, è facile accorgersi di un nuovo approccio, un cambiamento di genere avvenuto in maniera spontanea: «Credo di aver trovato la mia dimensione nel genere che faccio ora, credo si possa definire un indie-pop/ cantautorato». Parliamo anche del processo di scrittura; di cosa rappresenta per lui mettere nero su bianco le proprie emozioni. Una valvola di sfogo per chi sente tanto ma esterna poco, ma anche un modo per dare voce a chi non ne ha: «Col tempo ho capito che ci sono ragazzi che si rivedono in quello che scrivo. Questa per me è la soddisfazione più grande. Solitamente scrivo di getto, senza pensare troppo alle parole, ma piano piano sto imparando anche a cercare l’ispirazione quando sembra non esserci, soprattutto ora che lavoro anche come autore per altri artisti». E dove si trova l’ispirazione? Ovunque, nel quotidiano, qualsiasi piccola azione può diventare nutrimento per sviluppare una piccola storia da mettere in musica. Tutto sta nel come guardi le cose, come dice Marco.
L’adrenalina per il nuovo progetto che sta per andare in pubblicazione si fa sentire: ha annunciato da poco l’uscita del suo EP dal titolo “Astronavi & Carriattrezzi”. Parlerà di amicizia, amore, insicurezze e della vita in provincia. «Sono davvero contento del risultato e spero che piaccia anche a chi mi ascolta. Il primo estratto si intitola “Davvero” e uscirà il 9 Settembre», conclude prima di salutarci. E come sto? Bene, se c’è una chitarra nuova e una canzone da cantare…

Michele Sotgia e le scarpe made in Urzulei
di Augusta Cabras.
Nella via San Giorgio a Urzulei, un giovane calzolaio da qualche anno realizza scarpe in pelle su richiesta, per giovani e anziani di ogni parte della Sardegna, e non solo. Michele Sotgia, 33 anni, nato e cresciuto a Urzulei, con un diploma da ragioniere in tasca, con passione ed entusiasmo mantiene in vita un mestiere che rischiava di scomparire. «Ho sempre lavorato nel market della mia famiglia, e ancora, ogni giorno, do anch’io una mano, ma l’idea e la possibilità di realizzare le scarpe mi piace moltissimo».
E così Michele qualche anno fa ha iniziato ad apprendere l’Abc del mestiere, osservando il lavoro di altri calzolai che ancora operano in Sardegna, a Borore, a Gavoi e a Orgosolo, in particolare. L’osservazione e la sperimentazione sono andati di pari passo, tra qualche errore iniziale e il miglioramento continuo, determinato dalla costanza e dall’impegno quotidiano. «Ho iniziato ad acquistare le attrezzature e le macchine per cucire – racconta –, ho contattato i fornitori per avere la materia prima e ogni giorno sono qui, in questo spazio, a realizzare le scarpe».
Tra i rotoli di pelle di vacchetta arrivata dalla Toscana, adagiati su uno scaffale in attesa di essere lavorati e le suole realizzate nelle Marche, Michele si muove con scioltezza. È a proprio agio con i trapanti e i trancetti per scarnire la pelle, tra la pressa e il banco per il finissaggio. Ogni gesto delle mani mostra precisione e sicurezza, cura del dettaglio per un prodotto artigianale di grande qualità. Per realizzare un paio di scarpe Michele lavora, ora, per almeno quindici ore. Agli inizi aveva bisogno di una settimana intera. Adesso sono due i giorni di lavoro intenso, in cui ogni passaggio non lascia nulla al caso. Dalla misura del piede del cliente al disegno sulla pelle che diventerà la tomaia, dalla cucitura al bagno nell’acqua della concia, dall’attesa che tutto prenda forma fino alla consegna. Ma chi è che ancora compra calzature che hanno un prezzo importante e un tempo di realizzazione così lungo? «Sono soprattutto gli uomini, (ma è capitato di realizzarle anche per le ragazze), che le usano sia per lavorare in campagna o stare in montagna, sia per normale uso quotidiano, ma sempre più spesso anche per occasioni speciali. In questo caso il disegno cambia e la forma è molto più elegante».
L’odore della pelle lavorata sale dal banco di lavoro di questo giovane appassionato. Si mescola con il suono di una vecchia ma veloce macchina da cucire che ricorda i tempi passati. Sembra di rivedere qualche foto in bianco e nero. Eppure nella bottega di Michele il vecchio e il nuovo si mescolano con ordine, il legame con la tradizione sarda si lega in maniera evidente alla propensione a pensare in modo nuovo, a rinnovarsi, per crescere ancora e uscire dai confini locali. È una partita tutta da giocare ma il coraggio e l’entusiasmo sembrano non mancare. «La mia compagna Giustina – continua – mi incoraggia e l’apprezzamento delle persone che scelgono le mie scarpe mi spingono ad andare avanti. Le difficoltà ci sono. I costi della materia prima, ad esempio, sono molto alti, così come sono tante le ore di lavoro per un singolo paio di scarpe, ma io cerco di migliorarmi sempre. Mi piacerebbe che questa attività da hobby diventasse il mio mestiere. Ce la sto mettendo tutta».
È bellissima la passione che Michele trasmette. E pensare che tutto è nato per caso. O forse no.
«Un giorno mia madre invitò il calzolaio del paese, nell’ambito di una manifestazione organizzata dalla pro loco del paese, perché facesse una dimostrazione del suo lavoro. Il calzolaio, forse stanco, rispose che non aveva molta voglia e propose a me di farla. Mi incuriosii, osservai, provai, chiesi ai miei amici cosa ne pensassero. Tutti i pareri furono positivi e favorevoli, così volli provare. Per curiosità, per la voglia di cambiare e per vedere quanto potesse essere gratificante a livello personale. Ci ho creduto veramente e ora eccomi qui, a dedicare il mio tempo a questa attività».Mentre mi racconta la sua storia e mi descrive ogni passaggio che la creazione della calzatura richiede, i suoi occhi brillano e qualche perla di sudore si affaccia sulla fronte. C’è fatica ed emozione. Le mani sono svelte, si fermano solo per sentire se la rifinitura è perfetta, se la cucitura tiene ben aderenti i due pezzi di pelle. «Ci vuole pazienza», mi dice sorridendo. E come non dargli ragione! Non può esserci fretta se si vogliono fare le cose bene.
Intanto penso che in questi ultimi anni l’interesse per l’artigianato e per quei mestieri che stavano scomparendo è aumentato. Il miraggio del posto fisso (statale) ha forse permesso la rivalutazione della necessità che alcune professioni non scompaiano ma siano riprese, con uno sguardo rivolto alla ricchezza che arriva dalla tradizione, dall’esperienza di chi ha lavorato prima, dalle radici alimentate dalla storia e della cultura popolare insieme alle nuove intuizioni, a uno sguardo rinnovato sul futuro, ai vantaggi che la tecnica e la tecnologia oggi mettono a disposizione. Sostenere anche con incentivi questo settore potrebbe essere una buona cosa. Intanto è bello sapere che le figlie di Michele, Rita e Maria Francesca, di quattro e due anni, e con loro le nuove generazioni, possano ammirare il lavoro minuzioso del loro padre e dei nuovi artigiani e possano vedere nascere una creazione, con la curiosità tipica dei bambini. «Le mie bambine vengono qui – sorride – sono incuriosite dagli attrezzi che uso, osservano quello che faccio, come muovo le mani». Ed è grazie a persone come Michele che la bellezza dell’artigianato resiste, si conserva e viene preservata dall’oblio.

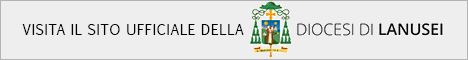

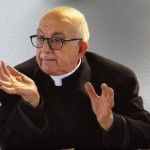





.png)