Volti e persone

L’arte? Eterno dialogo con il mondo
di Claudia Carta.
«L’arte è linguaggio, la massima esaltazione del pensiero umano, capace di trasmettere emozioni e messaggi. È immaginazione, fantasia, creatività. Un contenitore di forme d’espressione. Alla base delle sue esigenze e caratteristiche, l’uomo cerca al suo interno la risposta o forse se ne pone delle altre, indagando sul perché. L’arte è dialogo con il mondo. Il mondo esiste, ma l’artista lo ricrea continuamente dandogli nuovo significato».
Luca Rossi. È il nome che dà voce a parole vissute, prima ancora che scritte. La terra del vento: Ulassai. La sua casa. Classe 1981. Parola d’ordine: creare. «L’atto creativo è un istante, un attimo. I sentimenti li provi prima dell’istante, dopo subentra la razionalità della tua formazione».
Ecco, la formazione. Istituto d’Arte di Lanusei, sezione legno. Arriva da lì «l’imprinting con la materia». A seguire, Accademia di Belle Arti di Sassari e biennio specialistico nella scuola di Scultura. Stregato dalla materia: «Le caratteristiche del materiale – spiega il giovane artista ulassese – la sua essenzialità, la sua natura, la sua storia ed evoluzione diventavano parte dell’opera stessa, come se io e il legno o la pietra lavorassimo insieme per creare qualcosa. In un secondo momento la pietra è diventata la protagonista assoluta dei miei lavori, forse per il suo carattere più astioso, come un’amante che chiede maggiori attenzioni. O magari perché ha un rapporto con il tempo molto più sedimentato. La pietra ci precede e ci sopravvive, e questo rapporto con il tempo mi affascina molto di più».
La bellezza. Mani che toccano la terra, plasmano, danno vita. Le radici? Ai piedi del Tisiddu: «Una parte fondamentale, seppure ingenua, l’ha avuta il lavoro di mio padre, muratore. Questo mi ha permesso di avere un rapporto con il materiale molto disinvolto, come se la figura paterna si fondesse con la manipolazione, con il gioco delle mani e del materiale. Una sorta di benedizione. E poi c’è il rito della panificazione che sconfina nella scultura, tipica della mia zona e che mia madre padroneggia sapientemente».
Mani. Tacchi. Appartenenza: «Essere diviso tra Sassari e Ulassai. Il bisogno di sentirmi radicato a qualcosa, di ritrovare appartenenza ha fatto comparire nelle mie sculture nodi di varia forma e grandezza: corda grezza che facevo oscillare, come pendoli che lasciavano traccia sulla terra, prova del mio passaggio, e poi nodi di ferro che intrappolavano pietre, come se ingaggiassi una battaglia – persa in partenza – con tempo e spazio. Da qui ho iniziato a lavorare sull’oscillazione con la serie “Perdas Lebias”. La pietra non era più scolpita ma lasciata pura, sostenuta solo da un nodo scorsoio in ferro che la eleva verso il cielo. Un lavoro nato pensando ai Tacchi che caratterizzano il nostro territorio».
La materia diventa infinita e racconta gli anni belli, dice di felicità e giochi, di piazze, di sogni ed emozioni. Di Laura: «Il ferro è il materiale che preferisco in questo periodo e che ho impiegato anche per l’installazione realizzata per la Piazza Barigau a Ulassai. Ho voluto omaggiare l’infanzia con nove sagome di bambini che giocano a pallone, eternizzando il momento più magico della nostra vita, consapevole del fatto che di lì a poco sarei diventato padre. Tanto devo a Laura, mia moglie».
Arrivano le esposizioni. Momenti fondamentali per Luca «perché – fa notare – la ricerca artistica non è e non può essere solo un fatto solitario. Necessita di dialogo». Momenti chiave: «La prima volta che sono stato invitato a esporre in una casa cantoniera a Villanova Monteleone o la partecipazione a una manifestazione dedicata agli studenti di belle arti a Bilbao. Momenti di crescita in cui semplicemente mi sono domandato il senso del mio cammino».
Il Nord. Il Sud. L’Est. L’Ovest. Federico Soro, guida nella sua specializzazione; Sisinnio Usai, docente di anatomia artistica; Salvatore Ligios, docente di fotografia; Sonia Borsato che insegna Fenomenologia e oggi cura le personali di Rossi. «Ogni docente che ho frequentato, a suo modo mi ha caratterizzato. Quattro figure, quattro realtà che considero i punti cardinali della mia formazione artistica».
Ogliastra, fucina di artisti? «Si, sono d’accordissimo visto alcuni risultati. Penso che in Ogliastra ci sia un ambiente favorevole per la formazione di individualità culturalmente e artisticamente rilevanti. Stazione dell’Arte, Museo civico Albino Manca, “Su Logu e s’Iscultura”, l’Istituto d’Arte di Lanusei, sono luoghi delegati all’apprendimento di un percorso che mi piace identificare come “cura dell’anima”.

Nascere due volte
di Fabiana Carta.
Ci tiene a dirlo: la Sardegna, statisticamente una delle regioni con il reddito più basso, è quella che adotta il maggior numero di nuclei di bambini, ovvero gruppetti di fratelli. Perciò saremo anche poveri in termini di soldi, ma in termini umani e di solidarietà sociale possiamo dare l’esempio. Lei è Carla, tortoliese da generazioni, una donna appassionata che mi racconta, con grande intensità di sentimenti, l’esperienza travolgente dell’adozione. È un incontro di vite, è un percorso interiore da entrambe le parti, che porta a scavare nell’animo, ad andare oltre, a prendere consapevolezza del fatto che tutto questo comporterà un costo emotivo enorme.
Carla Sardano e suo marito Livio Angoletta vivono da circa due anni e mezzo con quattro bambini colombiani: Nick (15 anni), Esteban (13), Jesus (11) e Mara (9), li vedo sorridenti nelle numerose foto esposte in casa. Umilmente mi dice subito che l’adozione di un nucleo così grande non deve essere motivo di elogio, perché esistono anche famiglie che decidono di prendere con sé bambini con handicap o patologie gravi. «Spesso mi sento dire: sei coraggiosa. Ma nella vita bisogna lottare, rischiare. Se una coppia desidera dei figli e non riesce ad averli, questo non deve considerarsi un limite. Adottare significa aprire la mente a 360 gradi, accettare che non lo hai partorito tu. Ma il fatto che non l’hai partorito non significa che tu non possa sentirlo tuo, che tu non lo possa amare nello stesso identico modo».
È una scelta che parte da sé stessi, consapevole e responsabile, ponderata, che ti coinvolgerà per tutta la vita, come dice Carla «bisogna uscire dalla nostra zona di confort, non dobbiamo subire la vita, ma dobbiamo esserne attori, con tutti i rischi a cui si va incontro. Ma oggi posso dire che questa scelta ha dato qualcosa a tutti in termine di ricerca e arricchimento personale». È un dare e un ricevere continuo. Proviamo a tornare indietro nel tempo, al momento della scelta dei bambini e al primo incontro con loro, per capire cosa ha significato e come lo hanno vissuto.
Lo sguardo di Carla si fa serio e commosso. Ricorda quando ormai, dopo tutto l’iter, erano pronti a fare una scelta e l’ente a cui si erano rivolti (l’Ai.Bi.) aveva fatto loro la proposta dei 4 bambini, che osservarono in un video: «Di fronte a quelle immagini non potevi non farti coinvolgere, siamo rimasti folgorati. Mio marito appena li ha visti ha detto: “Dove devo firmare?”». La loro idea iniziale era quella di adottare un nucleo abbastanza numeroso, come tre fratelli, ma quattro proprio non se li aspettavano.
È stato amore a prima vista. L’incontro faccia a faccia, sguardi su sguardi, è avvenuto a Bogotà, la capitale della Colombia, nell’orfanotrofio che ospitava i bambini da quattro anni e mezzo. Bambini che prima di venire affidati all’istituto avevano trascorso una vita difficile, fatta di stenti, di maltrattamenti, di mancanze serie, a iniziare semplicemente dal cibo. «Io e mio marito tremavamo dall’emozione nell’attesa di vederli, in vita mia non avevamo mai provato qualcosa di simile, è difficile da tradurre in parole. Ci tenevamo la mano, ci sorreggevamo l’una con l’altro». E continua: «Non è stato facile, ma la cosa importante è che abbiamo dato loro un’opportunità e anche noi ci siamo arricchiti molto. Ci hanno insegnato una prospettiva nuova con cui guardare il mondo, diversa da quella a cui eravamo abituati. A volte, purtroppo, abbiamo l’abitudine di dare per scontate le cose, invece questi bambini ci hanno fatto capire che non bisogna mai farlo. Quello che per noi può sembrare banale, stupido, in realtà per loro ha un valore immenso».
Dopo un mese a Bogotà finalmente arriva il momento di tornare nella casa di Arbatax tutti insieme, proprio nel periodo in cui era scoppiata la primavera, metaforicamente un tripudio di luce, gioia e colori. Carla ricorda quei momenti emozionanti in cui i bambini hanno visto per la prima volta il mare e in inverno la neve. Lo stupore! «Erano inebetiti», come storditi da tanta bellezza. E poi via con le passeggiate sulla spiaggia, le gite verso i posti più belli del territorio, l’assaggio del cibo locale, le specialità. Due culture che si incontrano. Poi lo sport, utile per l’integrazione; i ragazzi fanno calcio, mentre la bambina ha scelto di fare danza, e un grande sforzo per fare in modo che ognuno di loro possa riuscire a esprimere la propria individualità.
Domando se abbiano mai avuto problemi a integrarsi a scuola e Carla coglie l’occasione per spiegarmi l’idea, ammirevole, che ha a riguardo: «Non hanno mai avuto nessun problema, ma gli abbiamo insegnato che essere diversi non significa essere inferiori, è giusto valorizzare le peculiarità di ognuno. Essere accettati non significa uniformarsi. Quindi si sono integrati, ma senza dimenticare le origini, il vissuto, il passato, perché io penso che uno non possa costruire sopra certe macerie, si costruisce a fianco».
Nick, Esteban, Jesus e Mara sono quella scintilla, quella ondata impetuosa di emozioni, di amore indescrivibile, di gioia che a volte diventa dolore quando riemergono vecchi ricordi. E allora come si fa? «A volte non è facile ascoltare i ricordi tristi dei loro anni in Colombia, ma tu genitore adottivo devi prendere sulle tue spalle il suo peso, i maltrattamenti, le bruttezze, gliele devi togliere e fartene carico tu. Devi esserci e basta, con tutta l’anima». Nonostante sia evidente, dalle parole di Carla, che non è facile mantenere tutti gli equilibri, emerge comunque il suo sguardo pieno di bellezza, di forza e di moralità. Perché quello che regalano i figli in termini umani non può dartelo nient’altro nella vita, tutto ciò che resta fuori, al di là della famiglia, sono solo cose, effimere e materiali.
Prima di salutarci si lascia andare a un pensiero che le fa tremare un po’la voce, «questi bambini prima o poi spiccheranno il volo, saranno autonomi, a noi sta il compito, il dovere, la responsabilità di dare loro gli strumenti per affrontare questa vita serenamente. Ci impegneremo a fondo perché un giorno possano dire “sì, siamo adottati, ma viviamo bene” e perché possano trovare il loro posto nel mondo. Andando via ripenso alla citazione preferita di Carla: i sogni sono per i coraggiosi, per tutti gli altri ci sono i cassetti.

Vestire la tradizione
di Claudia Carta.
Il cortile di casa è quello che sa di buono. È lì che ogni cosa trova il suo posto. Un profumo familiare che avvolge i muri e le pietre. Anche la terra ha il suo odore. Volti, mani, passi che lo attraversano, cogliendone l’intimità e aggiungendo ogni giorno un nuovo dettaglio che cambia la storia, ma non la sua essenza. E il tempo vola. Fra infiniti cortili, le cortiggias.
A Lotzorai ogni anno la primavera veste di nuova vita le antiche corti delle case, combinando passato e presente, vecchio e nuovo. Il risultato è sorprendente. Ma cortiggias è anche e soprattutto identità, riscoperta attraverso la ricerca storica e documentaria. È nata così la prestigiosa mostra etnografica del costume lotzoraese, allestita da Giampaolo Murru. Classe 1982 e passione da vendere. I numeri? Notevoli: oltre 40 i costumi recuperati, i più antichi risalenti a fine ‘800; più di 3000 le foto storiche dell’abbigliamento tradizionale sardo, di cui 150 incorniciate; costante la collaborazione con il Museo nazionale Sanna di Sassari. Tessuti, colori, gioielli: Giampaolo li cura con attenzione e meticolosità e ogni nuovo pezzo acquisito è motivo di soddisfazione. Non finisce qui: un patrimonio di oggettistica relativa all’antico mondo rurale e contadino completano un tesoro di inestimabile valore per il centro ogliastrino.
Il cuore della tradizione che batte forte: «Un mondo che ho amato da sempre – racconta il giovane collezionista – ma che ho iniziato a seguire con grande coinvolgimento dall’età di 15 anni. Una mia zia mi fece dono di un fazzoletto risalente alla fine dell’Ottocento. È stato il principio di un percorso di ricerca costante: dettagli, manifattura, tessuti e tagli, colori e modelli. Le foto d’epoca mi hanno dato una grossa mano, in questo senso. Quando nel 2003 è venuta a mancare mia madre – avevo appena vent’anni – è stato proprio questo mondo che, più di ogni altra cosa, mi ha aiutato. E oggi, mi sento quasi debitore nei confronti di un passato così denso di storia, di richiami, di radici».
Gonne, corpetti, scialli, fazzoletti, camicie. Un’autentica cronistoria del costume lotzoraese (e non solo) antica come gli anni che sono passati, ma che Giampaolo riesce a far respirare e brillare di nuova luce. «Nel 2012 – continua il giovane titolare del Bar Giardini – ho avuto la gioia di battezzare la mia secondogenita, Melissa: tutti noi abbiamo indossato il costume tradizionale. E dal momento che gli invitati provenivano da paesi diversi, è stata un’ulteriore occasione per conoscere meglio anche i loro abiti e poter recuperare pezzi preziosi per la mia collezione: Talana, Arzana, Baunei, Ilbono, per citarne alcuni, ai quali si sono aggiunti, qualche anno fa, Desulo, Orgosolo e Dorgali. Il mio interesse, tuttavia, è principalmente rivolto all’Ogliastra e a Lotzorai in particolare».
Tra filo e ordito, si dipana il disegno di un amore autentico. Giampaolo non è solo a tesserne le trame. La sua sposa, Tiziana Pisanu e le sue bimbe, Vanessa, Melissa e Alessia, sono la sua forza più grande e la sua luce. Condividono con lui scoperte e novità: «Ogni mia folle proposta viene assecondata», commenta sorridendo. In una Lotzorai sicuramente bella. Ma la passione e l’entusiasmo di questi ragazzi lo sono infintamente di più.

Quel Sole che illumina il buio
di Claudia Carta.
Sulle spalle un paliacate, a raccontare al mondo il grande cuore del Messico. Poi c’è il suo, di cuore, che non smette di incontrare quello degli altri, i soli, gli umiliati, gli sconfitti. E lì, all’ingresso della sede Caritas di Lanusei, occhi tristi e spenti se ne incontrano parecchi.
Sarà il nome, Solei Sharaid Pineda Majia, “sole del Sahara”: «È un nome impegnativo!» dice sorridendo. Un sorriso magnetico. Un’energia che tutto avvolge e rigenera. Una gioia autentica. Eppure ci sono stati momenti nei quali questo sole si è oscurato e l’ombra del dubbio ha tolto luce a ogni certezza.
«Momenti durati anni», racconta Solei, partendo dal versetto 7 del Salmo 15: Benedirò il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. «Parole che mi toccano profondamente – continua – perché è lui che nella preghiera, nel silenzio, ti dà consiglio. Nei momenti più difficili della vita, quelli in cui magari dobbiamo fare una scelta importante, nei quali c’è in gioco la vocazione, la strada stessa che tu devi percorrere, il Signore ci mette sempre accanto delle persone di fede che ti indirizzano, ti aiutano a capire quale sia la cosa giusta da fare. Soprattutto con piccoli gesti. Mi ricordo una volta, entrando in una chiesa di Roma, incontrai una donna che teneva per mano il suo bambino. Non era una mamma italiana. Davanti alla statua della Madonna, il piccolo si fece il segno della croce con una devozione tale che io rimasi sbalordita. Un gesto che ha cambiato in qualche modo la mia vita. Mi son detta: «Non è possibile che un bambino di sette, otto anni appena, possa trasmettere più con i suoi gesti che con le parole! Ecco, il Signore si è fatto presente così».
2015, anno della misericordia. Il 4 ottobre dello stesso anno ha fatto la professione perpetua. Alle spalle un lungo percorso di preparazione e discernimento. Eppure, prosegue la giovanissima suora francescana, «era un periodo per me di confusione interiore. Mi sentivo sfinita. A disagio. Cerchi uno sguardo nel cielo e non c’è. Uno spazio in terra e non vi è. Se fosse un’immagine, sarebbe quella di un pozzo: sopra, nessuno che ti regge; sotto, il vuoto. E tu sospesa nel mezzo. Il dubbio profondo che questa non fosse la mia strada. Sono quegli istanti nei quali tu cerchi ovunque delle risposte. È proprio qui che Dio si fa presente e manifesta la sua misericordia. Da quel bimbo, l’immagine che la mia era una scelta giusta, radicale certo, ma giusta perché fatta per amore. E in quella semplicità, ho visto tutto l’amore che Dio mi offriva. Era lui che, in quel momento, cercava me».
Accanto a lei le consorelle. «Continuavano a dirmi: “Non sei sola, coraggio!”. Ecco, coraggio e pazienza. Perché poi tutto torna, tutto si spiega, tutto trova pace. Perché anche nel buio più totale c’è sempre lo sguardo di Dio, nonostante i tuoi sbagli, i tuoi errori, le tue debolezze, il tuo essere piccolo. Ricordo con infinita riconoscenza la nostra co-fondatrice, Suor Paola Maniccia: un bel personaggio! Lei è come una madre: ti fa fare esperienza, perché tu impari, anche dai tuoi errori, ma ti sta sempre affianco. E Suor Marina Cancellaro che mi ha sempre esortato a guardare la parte positiva di tutte le cose e vedere la parte bella di me: «Ma tu sei Sole – mi diceva – devi risplendere!».
E poi don Angelo, il confessore. Le sue parole continuano ad accompagnarla: «Non è bene che tu prenda una decisione radicale in un momento nel quale ti senti così. Sii paziente. È ciò che il Signore ti sta chiedendo: avere pazienza. Non agire immediatamente. Aspetta». E forse il Signore mi stava preparando a qualcos’altro, qualcosa di più grande che però andava preparato con cura. E don Angelo, che mi conosceva bene e mi ha visto crescere, infine, mi disse: «Fai la tua professione senza paura, perché questa è la tua strada». E aggiungeva: «Tu cerchi risposte da me, ma sei tu che hai la risposta dentro di te». Un’altra domanda forte: «Ti senti amata da Dio?». La mia risposta: «No». «È questo il problema – sottolineava –: tu predichi l’amore di Dio, ma non ti senti amata da lui. È molto diverso predicare e sentirsi amata». E lì, crolla tutto! Continuavo a ripetermi: «O Signore, ma finora cosa ho fatto? Aiutami tu, perché io non ci capisco nulla!» E trovavo il coraggio di dirgli: «Perché non mi sento amata da te? Senti, a questo punto io faccio silenzio: parla tu, perché io non so più cosa dire!».
Fra tanti, il consiglio più prezioso: pregare sempre. «Ricordo che stavo ore e ore in cappella, per cercare di sentire il mio Dio vicino. Nel silenzio ho sperimentato una cosa curiosa: dentro di me, inizialmente, c’era molto mormorio: cose, persone, attività, impegni. Successivamente ho cominciato a sentire una pace interiore molto forte, una purificazione. Hai presente la lavatrice? I panni vengono girati e rigirati, sbattuti di qua e di là, getti di acqua calda e fredda, ma poi vengono fuori candidi. Tutto questo “batti e ribatti” fa male: in un attimo metti insieme la tua vita personale, le tue vicissitudini precedenti, ciò che stai vivendo, la paura per il domani. Ma poi, pregando continuamente, sei una persona nuova, ti sei preparata a fondo per esserlo. È come quando devi suonare un pezzo: studi, provi, sbagli, ricominci, piangi perché non riesci. Fatica, impegno, stanchezza, ma poi senti tutta l’armonia».
Oggi Solei risplende. «Quando vivi situazioni come questa – conclude –capisci davvero cosa sia la sofferenza degli altri, senti ciò che vivono gli altri. Soffri con loro. E tutto cambia. Il Signore ti mette davanti, sulla tua strada, le persone di cui tu hai bisogno. Non ci sono a caso, ma ci sono per un motivo. A quelle devi donare il meglio di te. Fosse anche solo un sorriso. Devi guardare gli occhi».
Davanti a quegli occhi, le parole più belle: «Grazie per esserci! Non è scontato. Gli stai dicendo che grazie alla sua esistenza, tu sei felice!».

Silvia Mereu, l’arte in una formica
di Augusta Cabras.
Lo studio d’arte Ill’Art di Silvia Mereu è nuovo di zecca. Ai primi di dicembre ha aperto al pubblico nella piazzetta Roma di Tortolì, portando nel centro della cittadina colori, forme, arte e creatività.
E se lo Studio d’Arte Ill’Art (che sta per Illustrazioni Artistiche) è una novità, non lo è l’arte di Silvia e il suo straripante estro, rivelato e raccontato tramite le sue illustrazioni e le sue innumerevoli produzioni: acquerelli, monili, pitture e altri oggetti, in una mescolanza di materiali, colori e geometrie.
Silvia racconta della sua passione, che è un tutt’uno con la sua vita, con grande entusiasmo e un’energia contagiosa. Racconta degli anni passati nell’Istituto d’Arte a Lanusei, tra studio e nuove scoperte, degli anni passati a Firenze nell’Accademia delle Belle Arti, ricchi di incontri importanti, fermento culturale, colpi di fulmine per nuovi colori (come l’acrilico lucido), attività e sperimentazioni, per arrivare poi a Sassari dove concluderà l’Accademia.
In quegli anni di studio, Silvia si occupa principalmente di design e decorazione. Ricerca e approfondisce le caratteristiche dei materiali, ne indaga, nella mescolanza, la bellezza e la forza espressiva. Rimane affascinata dal potere dello specchio quale oggetto reale e metafora della riflessione del pensiero, dell’emozione, degli sguardi propri e altrui. Lo specchio inteso come gioco di luce, riflesso, bagliore, nitidezza, verità. Il tema è così interessante e ricco di implicazioni artistiche che Silvia ne fa oggetto della tesi di laurea insieme al tema del nudo nell’arte. Negli anni gli ambiti di interesse mutano e si arricchiscono di esperienza e curiosità e Silvia non si ferma mai. Nella sua vita arrivano anche due bambini, Emanuele e Domitilla che portano, insieme a tanta bella energia, nuovi mondi da esplorare e immaginare. Come quel giorno, quando Emanuele, allora poco più di due anni, chiede alla mamma: «Mamma disegniamo qualcosa insieme?»; tra vari colorati tentativi e ancora nuovi disegni, dal foglio bianco salta fuori una formica. Una piccola formica, nera, nuda come tutti gli animali del mondo, forse anche un po’ triste, certamente molto timida. Emanuele mentre la guarda divertito dice: «Mamma la vestiamo? La mettiamo in un posto?».
La risposta alla domanda di Emanuele è la storia di oggi. Uno studio d’arte costellato di formiche che vestono abiti, costumi per il mare, sognano, pescano, piangono e ridono, annunciano eventi, rimandano a versi di belle poesie. Ormai la formica è il tratto distintivo dell’arte di Silvia, unica e riconoscibile. Un’arte illustrativa e narrativa ma anche introspettiva. La formica non parla e non dice, ma esprime, racconta ogni volta nuove storie in luoghi del mondo e della fantasia, si emoziona ed emoziona, regala messaggi e raccoglie impressioni.
Silvia si serve di questo animale, piccolo ma notoriamente forte, quasi timido ma intraprendente, per dare ordine al suo caos creativo che è sempre in divenire, sollecitato e solleticato da nuovi incontri, scambi e conoscenze, non solo nel suo Studio ma anche in altri contesti, come quello della scuola. Silvia infatti, insegna Arte e Immagine alle scuole medie di Lanusei. Nello stare insieme ai suoi alunni, insegna e impara, contemporaneamente. A loro vuole trasmettere e stimolare l’amore per il bello, per ciò che può essere costruito e ricostruito a partire dalla propria visione delle cose, dalla propria sensibilità, dal proprio talento. Lei non ama l’arte che ricopia, l’arte che vive solo degli input esterni senza che questi vengano filtrati, impastati, rielaborati con e nel proprio mondo personale. E allora ecco che anche agli studenti, che nell’ideare il presepe non riescono a staccarsi dall’idea che questo debba avere necessariamente il muschio, così come sempre e per tradizione si è fatto, il suo invito è di cercare altre forme, altri modi, altri linguaggi, altri materiali che raccontino e portino il messaggio potente della natività, indagando dentro e fuori sé stessi, allargando il campo della conoscenza, buttandosi con coraggio e leggerezza su terreni finora inesplorati.
E in tutto questo guardare oltre il già noto c’è comunque spazio per le radici, la tradizione, la propria storia personale e comunitaria. C’è spazio per i luoghi, per i costumi sardi che scardinano qualsiasi teoria del colore, per i gioielli della Sardegna che vengono ripresi e reinterpretati, in forme nuove. Perché l’arte per Silvia è tale se è capace di rinnovarsi, di scartare l’ovvio, di spostare l’asse dell’equilibrio ogni qualvolta rischi di piegarsi su stessa. Questo modo di creare non implica, per quanto sia difficile da immaginare, l’ansia o la fretta di fare, anzi. Nel tratto di questa giovane artista c’è lentezza, precisione, pazienza e riflessione. Il flusso creativo internamente caotico fluisce con calma decisa, con amore per i dettagli e con lo studio del particolare che non appesantisce, ma regala un’arte leggera. Leggera come una formica.

Il ragazzo dell’olmo cavo
di Tonino Loddo.
Conoscendolo, gli erano stati dietro tutta l’estate. «La scuola è bella, imparerai tante cose e starai in mezzo a tanti bambini. Vedrai che divertimento!». Ed Ernesto aveva finito per crederci. Così, quando fu il 1 ottobre 1946, cartella in mano, si avviò a scuola. Il primo impatto fu eccellente. Un ragazzone di quattordici anni, ancora scolaro alle elementari, cavato dalla cartella un calamaio pieno d’inchiostro, l’aveva lanciato contro il muro della scuola dove s’era andato a spiaccicare. Applausi, risate fragorose. «A scuola ci si diverte davvero!», pensava, salendo i ripidi gradini della scuola, accompagnato dal fratello. Una volta dentro, la prima delusione. Dovunque un silenzio quasi cimiteriale: adulti col berretto in mano, donne con le spalle basse che parlavano sottovoce, nessuno che sorridesse almeno un poco.
Tenuto per mano, attraversa la ressa ed ecco i maestri. Ernesto non crede ai suoi occhi. Tre omaccioni occhialuti («non avevo mai visto uomini con gli occhiali»), accigliati e contegnosi. E avevano pure il pizzetto. Uno, perfino gli stivali. Un brivido gli attraversa la schiena. Con uno strattone si libera dal fratello e corre, corre verso la porta. C’è chi ride. Il fratello pensa di riacciuffarlo in un amen. Ma non è così. Il terrore gli raddoppia le forze. Guadagnata l’uscita, si getta a capofitto tra gli orti terrazzati sottostanti. Uno, due, cinque, dieci. Non fa neppure caso ai muretti che salta. Poi, nel vasto orto di famiglia si ferma. Si guarda intorno. Solo. Il fratello non aveva neppure provato ad inseguirlo. «No. La scuola non fa davvero per me».
Eppure, aveva a lungo sognato quel primo giorno di scuola. Immaginava che i maestri gli avrebbero insegnato ad arrampicarsi fin sui rami più alti degli alberi, a prendere la mira con la fionda, a scalare i costoni rocciosi, a colpire un bersaglio in corsa lanciando una pietra… Tutte cose che quei tre individui non sapevano certamente fare; figurarsi insegnarle!
Sta lì fino al pomeriggio. Al rientro nessuno fa molto caso a lui. È il penultimo di nove figli. Il giorno dopo al primo rintocco della campana è già per strada. Breve conciliabolo con due amichetti. Si va. No. Non a scuola. Manco a parlarne. Conosceva un luogo che faceva al caso loro. Una campagna in cui si trovava un grosso olmo cavo. Quello sarebbe stato il quartier generale. Così fu quel giorno e per molti mesi ancora. Vi giungevano al mattino. All’interno dell’olmo depositavano le cartelle e poi via a piazzare trappole per uccelli, a giocare a chi si arrampicava più in alto, a chi colpiva meglio il bersaglio…
Un giorno decisero che forse era il caso di tornare a scuola. Trovò ad accoglierlo un maestro diverso, altissimo. «Fai le aste!», gli intimò. E lui lo guardò sorpreso. Di aste non ne aveva mai fatte! «M’as intesu?», gli urlò con malagrazia. «Non sa neppure parlare il sardo, pensò. Bel maestro!». E più quello s’arrabbiava, più Ernesto si convinceva che la scuola non era roba per lui. Così ricominciarono le scorribande nelle campagne intorno all’olmo cavo, interrotte da qualche fugace puntatina a scuola. A fine anno giunse puntuale la zucca.
L’anno successivo la musica cambiò. La scuola era più organizzata e in caso di assenze prolungate si provvedeva ad avvisare le famiglie. Così le assenze si fecero sempre meno frequenti e mai troppo prolungate. Andava (quando ci andava!) a scuola controvoglia, senza interesse: rispetto ai suoi bisogni era solo una gran perdita di tempo. Ma, a fine anno, giunge, inattesa, la promozione. «Per incoraggiamento», disse il maestro con gli occhiali.
Intanto, Ernesto aveva preso a frequentare una delle tante botteghe del rione. Vi lavoravano due calzolai simpatici, grandi novellatori e là si riunivano gli uomini nelle brutte giornate. Gli volevano bene e gli avevano anche dato un ruolo: ogni lunedì doveva andare a comprare L’Informatore. Come gli piaceva stare a sentirli mentre raccontavano storie senza fine o discutevano di sport! Il giornale, poi, lo attirava e cominciò a prenderlo in mano. Fu il suo primo abbecedario. A motivo di questo nuovo impegno, le puntate all’olmo cavo si diradarono, ma a fine anno fu nuovamente zucca.
Ottobre sa di nuovo. Era giunta in paese una maestrina bella come il sole, gentile e sorridente. Un’orgolese, Ninetta Davoli. Abitava nel vicinato di Ernesto e volentieri si fermava a chiacchierare con le donne quando passava per strada mentre si recava in chiesa o tornava dalla scuola. Per prudenza, temendone i rimproveri per le sue assenze, lui le girava ben bene alla larga. E poi aveva un nuovo impegno. Passava, infatti, le giornate in compagnia di un puledrino dalla vita tormentata che aveva chiamato Arcilivrighi per quel suo goffo modo di incedere sfregando le ginocchia. Non era bello, ma era il suo cavallo e ne andava fiero. E quando entrava in paese ritto sulla sella, le bisacce piene delle patate dell’orto, Ernesto si sentiva un principe.
Quel giorno se la vide dinanzi all’improvviso, quando gli fu proprio impossibile scansarla. «Ma che bel cavallo! È tuo?» gli chiese, accarezzando il muso del puledro. Sapeva che non era un bel cavallo, ma quell’inatteso complimento lo riempì di gioia. «Sì, è mio». «Perché non vieni a scuola domani?». Come dire no a quel sorriso?!
L’indomani Ernesto è a scuola. E al pomeriggio, in un canto della grande cucina, fa i suoi primi compiti tra lo stupore di tutti. Quel sorriso aperto, quel dire e chiedere semplice ma affettuoso se li porta ancora dentro, dopo una laurea in lettere con Giovanni Lilliu e una vita trascorsa ad insegnare e a fare il preside. Sempre ricordando a sé stesso e ai propri alunni che l’insegnamento è prima di tutto un grande gesto di amore. Perché il vero insegnante può toccare una vita per sempre.

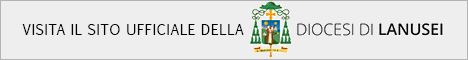







.png)


