Volti e persone

Pacha Mama. Bio? Logico!
di Augusta Cabras.
Fabiola Dettori per la sua azienda agricola ha scelto il nome Pacha Mama. Un nome musicale, dolce, che significa Madre Terra, dea dell’agricoltura e della fertilità. Elemento universale, presente anche in Sardegna. Per Fabiola è un nome e insieme una filosofia che presiede a un nuovo modo di pensare l’agricoltura, il cibo, la produzione e il consumo, la salute e il rispetto per la terra.
Fabiola, fino a qualche anno fa estetista di professione, è sempre stata appassionata di piante, fiori e terra. Da autodidatta ha iniziato a leggere e ad approfondire i temi dell’agricoltura biologica e sinergica e – un po’ per la voglia di sperimentare e molto per il desiderio di consumare e di far consumare alle sue due figlie, Anna e Maddalena e ai suoi familiari, prodotti genuini e sani – ha deciso, insieme al marito Sergio, di coltivare un piccolo orto, biologico e sinergico.
Niente diserbanti e fitosanitari chimici, ma fiori per allontanare gli insetti molesti, decotti di erbe da spruzzare sulle foglie di ortaggi e frutta, api per l’impollinazione, lombrichi per decomporre gli scarti, procedure che rispettano i tempi di crescita senza nessuna pressione sulla terra e i sui frutti; tanto lavoro con grande attenzione e profondo amore. Per la madre terra e per tutto ciò che sa regalare sotto forma di ortaggi, frutta, fiori e piante. Un trionfo straordinario di ricchezza e bellezza che nasce dall’atteggiamento di chi cammina sulla terra con leggerezza rispettando gli equilibri (spesso fragili), i tempi e le dinamiche naturali.
Dalla coltivazione di un orto per il consumo familiare, in due anni Fabiola è arrivata a coltivare due ettari, prendendo in affitto terreni e macchinari, grazie anche all’aiuto e alla consulenza dell’agronomo Giorgio Falchi: «Io non sono figlia di contadini, non ho terreni miei, né mezzi. Ho dovuto prenderli in affitto e darmi da fare. Ho frequentato un corso per diventare imprenditrice agricola, ma molto di quello che so lo devo alla mia grande curiosità e capacità di sperimentare».
Nel racconto di Fabiola, c’è la sua straordinaria energia, la voglia di portare avanti un progetto complesso ma appassionante, ricco di imprevisti legati anche alla situazione meteorologica, ma pieno di soddisfazioni. La certificazione Bio è arrivata dopo due anni di controlli, verifiche e ispezione sul terreno, sui prodotti e sui sistemi di coltivazione. Controlli severi e ripetuti nel tempo, effettuati da un ente preposto a garanzia della qualità e dell’essere biologico di frutta e verdura. Oltre il lavoro nella terra, Fabiola sostenuta in questa sfida da Sergio, non ha sottovalutato l’aspetto del marketing e della vendita dei prodotti. Oltre la rivendita sotto la propria casa, nel Corso Vittorio Emanuele a Bari Sardo, Fabiola ama il contatto diretto con i suoi clienti, sempre in crescita, facendo le consegne a domicilio anche in altri paesi. «In questo momento mi rendo conto di quanto siamo fortunati ad avere la tecnologia a disposizione per arrivare in tempo reale anche nei luoghi più distanti. Attraverso Facebook e soprattutto con il canale Youtube, raccontiamo in presa diretta, quello che si fa nel terreno, i mezzi che vengono usati (spesso realizzati con materiali recuperati e riutilizzati), quello che viene piantato e raccolto. Attraverso Watshapp invece mando settimanalmente ai gruppi d’acquisto presenti in tanti paesi dell’Ogliastra, la lista con i prodotti a disposizione e i prezzi. Ogni gruppo mi invia l’ordine e io provvedo a fare le consegne a domicilio. Per sistemare i prodotti uso delle cassettine di legno che il cliente mi restituisce in modo che non ci sia alcun imballaggio da smaltire». Un dettaglio importante e non banale che segna un cambiamento nel nostro modo di consumare, nel nostro modo di pensare avendo maggiore consapevolezza che il rispetto per l’ambiente passa anche dai nostri piccoli gesti quotidiani che possono fare davvero la differenza. In questo momento c’è certamente una maggiore sensibilità verso i temi della sostenibilità ambientale, della produzione e del consumo di prodotti biologici, della salute garantita o minacciata anche dal cibo consumato.
A Fabiola questo è chiaro e sente che anche in Ogliastra c’è sempre di più l’esigenza di fare agricoltura in modo nuovo, con più attenzione, con la conoscenza, la passione e anche la convinzione che ci sia una fetta del mercato che chiede prodotti di qualità, buoni, sani e senza residui chimici dannosi per la salute e che questi consumatori siano disposti a spendere in più per avere una tale garanzia. Perché, paradossalmente, i prodotti e tutto quello che serve per produrre in modo biologico e sinergico, costa il doppio di quanto viene speso per fare agricoltura convenzionale. Anche in questo caso servirebbe un ribaltamento di prospettiva per cui chi fa questo tipo di produzione, garantendo la naturalità dei processi, dovrebbe essere aiutato e sostenuto con premialità o costi di produzione più bassi. Un discorso lungo e complesso che chiama al pensiero e all’azione una politica che sappia avere una nuova visione di presente e futuro e che sappia percorrere sentieri nuovi.
Nei progetti di Fabiola c’è l’acquisto di nuovi terreni per differenziare la produzione e garantirne la quantità per i suoi clienti, c’è lo sviluppo della parte didattica dell’azienda, che diventerà multifunzionale, con la possibilità di accogliere gli studenti delle scuole alla scoperta di un’agricoltura sostenibile e biologica.
Perché le cose belle vanno raccontate, condivise e supportate. Fin da subito e costantemente.

D’amore e di coraggio
di Augusta Cabras.
È una storia d’amore questa. D’amore e di coraggio. Nasce con Paola e Andrea, si consolida con l’arriva di Elena, che oggi ha 16 anni, e si rafforza in modo speciale con la nascita di Giovanni, oggi tredicenne.
Paola inizia a raccontare tornando indietro nel tempo. Ripensa con emozione alla gravidanza, attesa e accolta con gioia; racconta la serenità dei nove mesi fino alle poche ore che hanno preceduto il parto, mentre lei è in ospedale e il travaglio ha inizio. Tutto sembra andar bene, quando improvvisamente e inspiegabilmente il battito del bambino inizia a rallentare, via via, mettendo in allarme medici e infermieri. In quel momento tutti si mobilitano perché la situazione non degeneri. Non c’è un minuto da perdere. Paola viene portata di corsa in sala operatoria: le luci e le voci dei medici fanno da sfondo all’effetto dell’anestesia che arriva poco dopo la consapevolezza che il battito cardiaco di Giovanni non si senta più. Poi il silenzio, nel sonno dell’operazione, e il buio. Paola si risveglia, al suo fianco c’è Andrea. Lui le chiede se ricorda e se sa cosa sia successo in quel tempo che è sembrato eterno. Paola risponde di sapere che il bambino è morto. Ha chiaro il momento in cui il battito si è fermato e quando il silenzio è diventato assordante. Andrea la ascolta e poi dice: «No! Giovanni è vivo!». Quelle poche parole spalancano nella mente e nel cuore di Paola una nuova e straordinaria possibilità. Giovanni è vivo, non tutto è perduto, la speranza e la forza della vita hanno vinto, il bambino e la sua tenacia hanno fatto il resto.
Un pediatra con coraggio, pazienza e determinazione è riuscito infatti, a rianimare Giovanni, sperimentando il fragile equilibrio della linea sottile che separa la vita dalla morte, la speranza dalla rassegnazione. Il desiderio della vita ha il sopravvento sulla paura e Giovanni è vivo, come nato una seconda volta. Fin da subito Paola e Andrea, decidono di affrontare la loro nuova vita passo dopo passo, nonostante le difficoltà che potranno presentarsi. É Paola a infondere coraggio a chi le sta vicino, a ringraziare la medicina e il Cielo per questo dono straordinario, nonostante tutto, nonostante una diagnosi chiara e complessa, a cui fa da contraltare, da subito, lo sguardo vivo di Giovanni e il suo sorriso disarmante che racconta di una voglia incontenibile di vivere.
Il primo periodo serve a Paola e Andrea per capire cosa poter fare per far vivere Giovanni nel miglior modo possibile. Chiedono aiuto, incontrano medici e operatori sanitari che diventano nel tempo punti di riferimento e pilastri per la vita di questa famiglia. Si informano, si spostano, approfondiscono, si confrontano con altre esperienze, meditano anche di lasciare la Sardegna per raggiungere altri luoghi dove la medicina o la riabilitazione, per chi come Giovanni ha una tetraparesi, è più avanti. Poi hanno un incontro con un medico che serenamente dice loro di non perdere tempo a girare il mondo per far star bene Giovanni. Il consiglio è di trovare qui una modalità per poter vivere bene, dove l’aspetto sanitario e della riabilitazione non tolga spazio e tempo alle relazioni e alle emozioni, che di fatto, saranno e sono tutt’oggi il cuore di ogni azione fatta per Giovanni e con Giovanni.
I due genitori fanno tesoro di questo consiglio e riorganizzano la loro vita personale e di coppia orientando il proprio quotidiano in modo nuovo, dando una luce nuova anche a ciò che da sempre ha fatto parte della loro vita insieme: la musica. Andrea infatti è un musicista, poli strumentista, insegnante di musica. La sua vita è con la musica. La musica quale mezzo potentissimo per raccontare e provare emozioni; strumento di condivisione di attimi che hanno il sapore dell’eterno, segno intangibile eppure reale di mondi sempre nuovi. É la potenza della musica, che in casa Nulchis-Mulas contagia prima Elena e poi Giovanni. É una musica che crea ponti e legami, abbatte diffidenze, cancella perplessità, facilita le relazioni. Anche per Giovanni. Lui che dimostra di aver un ritmo eccezionale, che legge e compone la musica, che suona in casa e fuori casa, che accompagna con le sue percussioni i tanti amici che nella sala adiacente alla sua cucina, prendono lezioni dal padre, ma poi si fermano oltre, perché in quella casa ci si sente tutti un po’ di famiglia. É la forza dell’amore, è la solidarietà libera, trasparente, spontanea; è ciò che viene generato, con un effetto moltiplicatore, dall’apertura verso gli altri, dall’accoglienza, dalla condivisione.
Andrea e Paola, infatti, non si sono mai chiusi nel loro mondo. Non hanno avuto paura della disabilità, rivelatasi nel tempo di tipo motorio, l’hanno guardata dritta negli occhi, senza sfida ma con la consapevolezza che si può e si deve scegliere. Loro hanno scelto di non perdersi nella triste rassegnazione e hanno tracciato sentieri nuovi. Hanno lasciato spazio a chi ha voluto aiutarli, hanno permesso ad altri che stringessero relazioni con Giovanni, liberandolo dal rischio di un loro attaccamento morboso. Sono stati coraggiosi, in un tempo in cui la ricerca della perfezione e dell’efficientismo a tutti i costi vengono sbandierati da più parti. E il tempo sta dando loro ragione.
L’accoglienza della vita e la condivisione del quotidiano hanno generato solo cose belle, per loro, per la loro grande famiglia e per tante altre persone. Paola, Andrea ed Elena, continuano a stupirsi di come l’energia di Giovanni e la sua voglia di vivere siano contagiose e come avvenga continuamente uno scambio di energia tra lui, la sua famiglia e gli altri. Una forza straordinaria che trova spazio nella scuola e nello studio, nella sua passione per la Ferrari e naturalmente nella musica che studia e suona, racconta e condivide con un numero sempre più grande di bambini, giovani e adulti. Come avviene, ormai da diversi anni a Tortolì, durante il concerto Il mondo di Giò. Un concentrato di suoni, parole, gesti, immagini e colori che sanno di gioia pura, amicizia e libertà.

Riflessioni di un guerriero
di Fabiana Carta.
Giammarco Mereu ti trapassa con lo sguardo, subito ti travolge. Le sue parole sono come iniezioni di energia, ti costringe a esserci, a esserci per davvero, in uno scambio di pensieri taglienti come lame. Giammarco non cammina ma vola. Vola alto. Questa è una storia di coraggio, di dolore composto, di grinta e dignità, che non trova spazio per la pietà o la commiserazione, quella la lasciamo ai deboli, a chi si lamenta ogni giorno senza muovere un dito per migliorare la propria esistenza.
Mi accoglie nel suo spazio più intimo, la sua casa, e conosco le persone più importanti, sua moglie e i suoi due figli; gentili e sorridenti. Non gli chiedo di parlarmi nel dettaglio del terribile incidente del 2006, quando a 37 anni finisce schiacciato sotto il cancello di 600 chili dell’azienda in cui lavorava, rompendo due vertebre che lo costringeranno alla sedia a rotelle: il mio corpo è per metà in sciopero – è sordo – ma il messaggio che manda è chiaro, è limpido, è atroce: non si cammina più, non si cammina più.
Dopo l’incidente si ritrova per sette mesi in ospedale con un busto in metallo e nelle notti sofferenti scrive delle poesie, delle riflessioni, “Memorie di un combattente”, che grazie ai registi Juri Piroddi e Silvia Cattoi diventano uno spettacolo teatrale per far riflettere sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. “Giorni rubati”, dove interpreta se stesso («non sono un attore, posso definirmi un operattore»), è oggi arrivato alla centosettantesima rappresentazione con la compagnia Rossolevante. Ma non finisce qui, negli anni sono nati altri lavori, come lo spettacolo “Stop making sense” e “Uomini”, fa tennis in carrozzina e ha preso il brevetto da sub arrivando 23 metri sott’acqua.
«Qual è il messaggio che vorrei lanciare? La vita è tosta e io sono arrabbiatissimo. Ma trovi delle energie che pensavi di non avere, escono fuori con prepotenza. Chi ha fede si attacca a Dio, come un’ancora di salvezza. Io sono ateo e non trovo risposte rispetto a quello che mi è successo, penso al destino o alla sfortuna». Già, la colpa… A chi destinare questo fagotto ingombrante se non al destino che lo ha confezionato? Mi confessa che non ha mai smesso di porsi questa domanda. Chiedo a Giammarco da dove nasce questo suo grande coraggio, doppio, perché da una parte con lo spettacolo ripercorre gli attimi dell’incidente tutte le sante volte che sale sul palcoscenico, dall’altra il coraggio di reinventarsi.
Cosa fare adesso? Come riciclarsi? Avevi una strada dritta e ben delineata, adesso ne hai una dissestata e con svincoli per te inaccessibili. La risposta, l’unico momento in cui leggo commozione nei suoi occhi: «Sei entrata in casa e quelle che hai incontrato sono le persone che mi hanno dato la forza di combattere, mi sono aggrappato a loro. Una frase che non dimenticherò mai, che mi disse mio figlio a 7 anni è stata: “Papà, ma torni a casa con la sedia a rotelle? – Non lo so – L’importante è che torni a casa”, rispose. Questo ti fa capire che, nonostante la menomazione, tu sei ancora utile. Sono in prima linea, con dietro un esercito di volontari che mi spingono a non mollare. In questo mondo si entra senza chiedere il permesso».
Penso che Giammarco abbia una sensibilità molto affinata, con una bella capacità di capire le situazioni e le persone in modo profondo, non tutti avrebbero saputo leggersi nell’animo come ha fatto, reagendo con grande fame di vita. Glielo faccio notare. «Credo che ci siano situazioni molto più gravi della mia, in particolare ricordo un ragazzo tetraplegico incontrato a Genova durante un laboratorio, che è riuscito anche a laurearsi e suona l’armonica a bocca. Di fronte a lui io alzo le mani e dico “sei un grande!”, è questione di prospettive».
Oltre le sue spalle vedo una grande libreria strabordante di volumi di ogni genere che denotano la sua grandissima curiosità e voglia di conoscere e approfondire; in alto, su un mobile, noto due premi importanti: la medaglia di rappresentanza ricevuta dal Presidente della Repubblica nel 2011 e il Premio Safety Leadership Event ricevuto nel 2016, per la capacità di trasformare un evento negativo in un evento positivo, perché portavoce di tutti quelli che hanno subito un incidente sul lavoro, per il coraggio di mostrare le fragilità e portarle in scena.
Grandi soddisfazioni. Gli chiedo a brucia pelo: com’era il Giammarco di prima? «Diverso. Più maschio e meno uomo. Più ovvio, meno profondo. Sicuramente passare per una strada così tortuosa ti costringe a trovare delle energie. Dal niente non si fa niente, forse ero una buona persona anche prima, come tante. Dentro di me c’erano dei valori che non avevo mai messo in evidenza, quello che è successo mi ha costretto a tirarli fuori. Rimettendo a posto i cocci ne è nata una persona indistruttibile, diversamente insuperabile». Due parole che riassumono l’uragano che ha dentro.
É già da un po’ che mi dimentico della sedia a rotelle. C’è solo lui nella stanza, un uomo schietto, ironico, senza fronzoli o barriere, un ribelle che non accetta la mediocrità, il perbenismo, che soffre l’indifferenza. Non basta vedere, bisogna guardare. Combattere, lottare per le idee, per i pensieri, allargando la visuale, nutrendo una rabbia che ti costringe a risorgere, lasciando fuori i superficiali, chi si piange addosso. Via sparite pensieri ovvi e formali non vi voglio non mi appartenete. Giammarco si augura di arrivare stanco al capolinea, ma con la consapevolezza di aver sfruttato al massimo tutte le possibilità che la vita mi ha offerto. Sarà sufficiente sapere che sono stato solo di passaggio. Un pensiero che riempie di speranza, in un mondo dove spesso siamo circondati da persone che non vanno oltre il loro ristretto orizzonte, sono di fronte a un uomo che è assettato, ingordo anche verso ciò che non ama. «Bisogna conoscere. La conoscenza non è mai abbastanza. Una vita non mi basterà. Io voglio essere una voce fuori dal coro». È come un corridore che si fa fatica a raggiungere. Memorie di un combattente si chiude con un verso significativo: Non farò mai un passo indietro. Giammarco aggiunge: «Anzi, forse farò un passo indietro per prendere la rincorsa!». In realtà non ne ha bisogno, Giammarco è già un passo avanti a tutti noi.

Sopportati? No, amati e capiti
di Fabiana Carta.
Parliamoci chiaro, quante sono le persone moleste che incontriamo lungo il nostro cammino e che tentiamo di sopportare pazientemente? Non ci basterebbero le dita di una mano per contarle. Ma se ci concentriamo sull’etimologia della parola sopportare, ragionando sul suo vero significato, potremmo leggere quest’opera da un’altra angolazione: dal latino sub–portare, reggere, sostenere. Ecco che sfuma, come una pennellata, l’unica accezione negativa che avevamo dato a quest’atto.
In Italia contiamo 2.293.778 adolescenti. Nella loro fascia d’età considerata “critica”, possono essere considerati molesti? Sì, se pensiamo alla loro voglia di cercare continue risposte, di provocare, di avere attenzione, sguardi, considerazione, affetto. I giovani sanno dare fastidio. Devono dare fastidio!
Mi confronto con tre ragazzi di 17 anni; Greca, Cristina e Daniele, per parlare di questo, ascoltando il loro punto di vista. Volutamente li provoco subito con una domanda: «Vi sentite così pesanti e rompiscatole da dover essere sopportati dagli adulti, che siano insegnanti, educatori, genitori?».
«Dalle insegnanti soprattutto – mi confida Greca – perché spesso a scuola portiamo i problemi che abbiamo a casa, perciò devono sopportare i nostri scontri».
Secondo Cristina invece non si tratta di questo: «Non è questione di problemi che ci portiamo dietro; dipende dalla situazione in cui ci si trova. Secondo me un adolescente non va sopportato!».
In modo naturale si delineano i loro caratteri e nascono le differenze di approccio alle situazioni: Greca è spumeggiante, travolgente, sanguigna. Cristina e Daniele sono più riflessivi e ponderati. «A volte riconosco che rispondiamo in modo brusco e gli adulti devono patire i nostri sbalzi di umore», continua Greca.
«Non sono d’accordo», ribatte Daniele.
A questo punto il discorso prende una piega più seria, con Cristina: «È un luogo comune che l’adolescente sia tormentato, che cerchi sempre lo scontro con l’adulto, che sia ineducato. Non siamo una categoria a parte, siamo esseri umani, come gli adulti! Io mi sento capita da loro».
Daniele prova a darmi una risposta diplomatica: «È ovvio che può capitare ogni tanto di discutere, ed è ancora più ovvio che capiti quando due persone vivono nello stesso contesto per tanto tempo, come in famiglia o a scuola. È impossibile trovarsi d’accordo su tutto. Personalmente non mi è mai capitato di non sentirmi capito o escluso dal mondo. Anche io credo sia più un luogo comune. Dipende dalle persone, dall’empatia che si crea; ci sono adulti che reputi più vicini a te e altri meno».
Gli adolescenti tormentati li troviamo solo nei film? Abbiamo uno scoop: i ragazzi sempre arrabbiati e insoddisfatti, che si ribellano a tutto e a tutti; che si chiudono nel proprio mondo troncando ogni dialogo con gli adulti; che sembrano non avere il minimo interesse per il proprio futuro e che, soprattutto, non riconoscono più alcuna autorevolezza ai genitori non esistono?
Ridono. «Secondo me il fatto di essere, a volte, scoccianti o fastidiosi dipende dal fatto che non ci sappiamo moderare o trovare un limite. Può capitare anche a casa di fare una fesseria, ma se poi si ripete…», confessa Daniele. È anche questione di carattere, di indole. Greca, disordinata con un’allegria contagiosa, ammette di aggregarsi al gruppetto che fa confusione in classe, di amare il caos, la baraonda. Si definisce il disordine in persona: «Ne ho combinato di tutti i colori!».
Mi raccontano che il fatto di vivere in un paese li salva da eventuali situazioni limite o di pericolo in cui potrebbero cadere, ma esiste un qualcosa che li unisce a tutti gli adolescenti del mondo: l’amore per il cellulare, compagno di vita e di avventure. «Il telefono vi isola?». «Più che altro ci distrae, ci fa perdere la concentrazione dallo studio, per esempio». Su questo punto ci tengono a precisare un altro luogo comune e sono tutti d’accordo, come spiega Greca: «Non è esatto dire che quando ci incontriamo con il nostro gruppo di amici non parliamo tra di noi perché siamo impegnati a controllare lo schermo del telefono! Mia madre mi parla dei tempi in cui alla mia età usciva con le amiche per fare grandi chiacchierate, ma anche noi facciamo lo stesso». Precisano che anche a tavola è bandito, è l’unico momento in cui si sta tutti insieme in famiglia, si mangia e si parla.
Mi trovo di fronte a ragazzi molto educati e rispettosi, nei limiti della pesantezza normale per la loro età, per niente fuori dal mondo e con parecchi interessi.
Cristina, frequenta la terza liceo classico come Daniele, ama l’equitazione, lo sci, la musica e il canto, le piacerebbe imparare a suonare la chitarra.
Daniele ama la musica, suona l’armonica a bocca e ama fare escursioni nel periodo estivo.
Greca frequenta l’Istituto Socio-Sanitario, adora cantare e ballare e ha un sogno nel cassetto: diventare un’attrice o una cantante di professione. Tutti e tre fanno parte di un gruppo Folk. Si sentono spesso vittime di critiche infondate, di pregiudizi e confronti, e allora via con chissà che ne sarà del loro futuro, gioventù bruciata, si stava meglio quando si stava peggio.
Insomma, la mia missione di trovare adolescenti “pesanti e molesti” è (felicemente) fallita?

“Io non ho paura”
di Claudia Carta.
Morire e rinascere. Lo si può fare in tanti modi. A volte è sufficiente avere un cuore che fa le bizze. Oppure si può semplicemente raccontare “quella volta che ho rischiato di morire”. Capita a tanti. La differenza? La differenza la fa sempre il pensiero, dove pensiero significa riflessione, meditazione, capacità di guardare tutto ciò che accade con gli occhi non del fatalista, ma di chi vede tutto, e tutto accetta, con fede.
Basilio Asoni. Prima delle parole, arriva il suo sorriso. E quella ferma, incrollabile serenità. In una mano il “telecomando” del suo cuore “capriccioso” che spesso e volentieri si fa sentire. Nell’altra, la corona del Rosario. È nato nella sua casa di Loceri un venerdì santo di sessant’anni fa: «Non sarei nemmeno dovuto nascere – racconta con ironia – o sarei dovuto morire dopo qualche giorno, dato che mia madre ha visto morire tutti i figli maschi al momento del parto. I nove mesi di gestazione si erano già conclusi, ma di nascere, evidentemente, non ne avevo proprio idea! La sera, come da tradizione, tutti i miei familiari si recarono alla Via Crucis. Mia madre rimase tranquilla a casa. Al loro rientro, accanto a mia madre, trovarono anche me. Fu festa grande: un figlio maschio nato vivo! Era abitudine che la casa venisse scaldata accendendo un gran fuoco e preparando dei bracieri per mantenere costante il calore. Così fece mia zia Maria. Tutta la notte. La mattina, al suono dell’Ave Maria, i vicini di casa si preoccuparono non vedendo ancora le imposte aperte e il fumo venir fuori dal camino. Data la stranezza della situazione, si precipitarono in casa. Ci trovarono tutti addormentati, storditi dalle esalazioni. Ero attaccato al seno di mia madre. Mi portarono subito fuori, all’aria aperta. Con me, si salvarono anche gli altri».
Di disavventure come queste, Basilio ne ha vissute tante. E le racconta con il piglio di chi, grazie a Dio, le può riportare sorridendo. Come quella volta che, a cinque anni, durante la festa di Sant’Isidoro, is bois mudaus, passavano per le strade del paese tra fiumi di gente a festeggiare il raccolto: «Con la curiosità che hanno tutti i bambini, mi avvicinai verso uno dei buoi che, per tutta risposta, mi raccolse a cornate. Ricordo che mi aggrappai forte alle sue corna, mentre andavo su e giù in un’altalena continua. La folla atterrita. Io con un bel taglio sulla testa. E finalmente un uomo che, alle mi spalle, mi afferrò sollevandomi in alto, strappandomi dalla presa dell’animale. In quegli stessi giorni, a Tertenia, un bambino era morto nello stesso identico modo».
Oggi Basilio ha tre belle figlie: Francesca, Federica e Fabiana. Anche lui con la sua sposa, Romana Ligas, ha vissuto la sofferenza di quattro parti andati male. Ma se la volontà altrui era questa, null’altro si poteva fare se non accettarla. Amante delle ricerche d’archivio, delle tradizioni legate al suo paese, di storie, voci e volti di Loceri, l’impiegato comunale tutto scrive, annota e registra con passione, intervistando gli anziani e facendo tesoro «della loro scienza». Fra le tante storie, una gli è particolarmente cara: quella legata alla realizzazione della chiesa dedicata alla Madonna di Bonaria, a Monte Cuccu, e a un sogno che, fatto centocinquant’anni fa, nel 1863, da una donna definita impropriamente “sa serbidora”, ha visto la sua realizzazione il 2 agosto 2013, quando la chiesetta è stata inaugurata e benedetta da don Elio Mameli, proprio là, sull’altura che si affaccia sull’incantevole lido di Cea: «A questa giovane donna – spiega – apparve in sogno la Madonna di Bonaria chiedendo che nel punto da lei indicato, Monte Cuccu, venisse costruita una cappella in suo onore. Le ossa della donna furono conservate nel vecchio cimitero di San Pietro apostolo, dietro l’altare maggiore. Da qui vennero spostate alle tre del pomeriggio del 4 marzo 2008, per la costruzione del nuovo oratorio parrocchiale».
Una data che Basilio ricorda perfettamente. I lavori per il nuovo oratorio procedono spediti: le ruspe lavorano incessantemente per buttare via il vecchio e preparare gli spazi alla nuova costruzione. L’impiegato comunale si trova spesso a fare sopralluoghi nel cantiere: «Ricordo che attaccato alla parete c’era ancora una grande crocifisso a cui, però, mancava un braccio, sicuramente staccatosi durante i lavori di demolizione. Mi riproponevo, ogni volta, di passare per cercare di trovare là vicino il pezzo mancante, così da poterlo sistemare e riutilizzare ma, per un motivo o per l’altro, rimandavo. Un pomeriggio, prima di rientrare in servizio alle tre, decisi di andare a fare la mia ricerca. Entrai in quello che restava della palazzina diroccata. Feci la prima rampa di scala quando il campanile batté le tre. “È già tardi, pensai, non faccio in tempo, devo arrivare in comune”. Tornai sui miei passi. Nemmeno il tempo di mettere il naso fuori dalla vecchia porta che l’intero solaio crollò, diventando un pavimento. Una nuvola di fumo immensa mi avvolse. Ma ero vivo. In piedi. Lo spazio di un respiro».
E poi c’è il cuore. Che rallenta fino quasi a fermarsi. Un dolore intenso e questo senso di stordimento: «Quando succede, prendo subito in mano il Rosario e prego – commenta mostrando la corona che porta con sé –. Faccio lavorare il cervello e cerco di stare sereno. Mia madre mi ripeteva sempre: “Non devi avere paura della morte, ma dell’ora, di quel momento”. E quando prego, so di non essere solo». E aggiunge: «Nel gennaio del 2015 mia moglie si sente male. L’accompagno al pronto soccorso. In realtà, mi accorgevo che anche io stavo poco bene. Il solito dolore acuto, la stanchezza, la sonnolenza. Mi sdraio su tre sedie, nell’andito del reparto di chirurgia. Una luce fortissima e io che corro all’indietro, sempre più veloce. Poi una forza immensa che mi trascina. Non so quanto sia durato tutto questo. Ma quando sono tornato, ho visto tutti i medici attorno a me: “È andato, non c’è più nulla da fare”. Lì con loro anche mia figlia. Ma io c’ero. Ancora una volta».
La morte fa capolino. Basilio lo sa. È pronto: «Io non ho paura. Quando succederà, avrò il Rosario con me e la certezza che Dio c’è. Niente, nella vita, è più naturale della morte». Sorride. Sempre.

Sport, un progetto di vita
di Bruno Mulas.
Valle del Pardu, un microcosmo incastonato nei Tacchi. Bello nascere e vivere in questi luoghi, ti senti parte di qualcosa di bello. Ma, ahimè, c’è il rovescio della medaglia. Il lavoro. Il lavoro che nobilita e affranca dal bisogno, che restituisce dignità. Il lavoro che manca, soprattutto per i giovani. Lo spettro dell’emigrazione, quasi dimenticato, è lì, dietro l’angolo, a strizzarti l’occhio, a incitarti a scappare. Che tu abbia ingrossato le fila dell’abbandono scolastico precoce, che abbia raggiunto titoli accademici o che sia un emigrato di ritorno, la disoccupazione miete, quasi indistintamente, le sue vittime. Che fare? Dubbio amletico che ha messo a dura prova le teorie di grandi uomini.
Eppure nella fitta nebbia dell’incertezza e dello scoramento, qualche luce tenta di squarciare l’ombra nefasta del fatalismo che governa questi tempi. Caparbiamente ha completato il suo ciclo di studi che, in teoria, dovrebbe aprire tante porte. Altrettanto caparbiamente decide che è qui che deve mettere a frutto gli anni dedicati allo studio.
Nicola Pilia, 24 anni, padre ulassese e madre jerzese, laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive, e solo perché per la specialistica bisogna emigrare in continente, sportivo a tutto tondo – calcio, milita per la A.S.D. Ulassai 2° categoria, atletica – ha deciso di mettersi in gioco.
Ma che ti è saltato in mente? Una palestra nel cuore dei Tacchi, magro bacino d’utenza. Come mai?
Mi guarda dritto negli occhi, sorride: «Sono ottimista. Durante il corso di studi universitari ho sempre pensato di impegnarmi in qualcosa del genere. Al conseguimento della laurea non ho voluto star fermo ad aspettare che il lavoro venisse a me e ho tentato di costruirmelo da solo, dando sfogo a quelle che sono le mie aspirazioni. Poi nella Valle del Pardu c’è tanto da lavorare nel settore. Bisogna costruire una mentalità attenta a quelle che sono le tematiche della forma e della salute fisica; la cultura del salutismo e della cura personale attraverso l’attività fisica mirata è ancora agli albori. Ho voluto e voglio impegnarmi in qualcosa che mi piace, che mi appassiona, che dia un senso compiuto al mio curriculum scolastico».
Nicola è un fiume di parole difficile da arginare, lui stesso mi chiede aiuto per metterne in ordine il flusso: «Brù, fammi delle domande precise!». Obbedisco.
Questa è la tua prima esperienza lavorativa?
«No. Nel corso degli studi, nelle pause estive, ho sempre lavorato. In costa, salvamento a mare: bagnino. L’anno scorso ho seguito una ludoteca estiva per il comune di Ulassai. Attualmente sto dando attuazione a un progetto di psicomotricità che ho presentato alle scuole della prima infanzia. Prodotto tipico del mio titolo professionale. Sono state belle esperienze che mi hanno permesso di approfondire e toccare con mano problematiche fino ad allora relegate alla teoria dei testi scolastici. Ecco, questo mi piace. Impegnarmi con le persone, seguirle nei percorsi di educazione fisica e di recupero dei deficit congeniti o indotti».
Idee chiare, tese a realizzare un progetto di lavoro che non si ferma a quello dipendente, magari a tempo indeterminato, ma spazia nelle possibilità che offre l’acquisita formazione universitaria. Mettere in pratica i progetti pensati e studiati, rischiando in prima persona.
Cosa chiedi al progetto di lavoro che hai intrapreso, qual è il sogno che intendi realizzare?
Nicola cerca le parole, rallenta il ritmo, vuol far capire esattamente cosa intende fare.
«Mettere su una palestra tutta mia, che sia un centro fitness professionale, ma non solo. Collaborare con altre figure professionali specializzate in singoli settori per offrire servizi diversificati e altamente professionali. Recupero fisico dei post traumatizzati, assistenza con personal trainer per differenti fasce d’età recanti diverse problematiche. Collaborazione con strutture sportive impegnate in varie discipline. Offerta di servizi mirati per le scuole. Insomma, valorizzare appieno la mia figura professionale che ancora non trova giusto riconoscimento».
Un bel progetto, ambizioso, che rende giustizia alle aspirazioni di giovani che si vogliono misurare nel difficile ambito dell’imprenditoria, in un territorio che ancora sconta il mancato sviluppo industriale iniziato negli anni sessanta e oggi in agonia.
Occorre coraggio, preparazione, impegno, entusiasmo e passione.
Nicola ne ha da vendere.

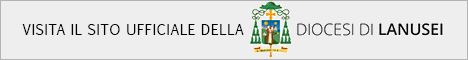







.png)


