Volti e persone

La verità nelle carte
di Alessandra Secci.
Verba volant, scripta manent: come recita la celeberrima locuzione latina, le parole si librano nell’aria, quel che è scritto invece resta. Ed è così, le carte sono un’entità, un organismo dormiente ma vivo, una sorta di scrigno analogico pronto ad aprirsi in qualunque momento e a raccontare. E raccontano. A volte narrano, altre strillano, denunciano, sentenziano. Anche quelle più incomprensibili, scritte in idiomi antichi e in grafie imperscrutabili. Lo sa bene Tonino Serra, che di ardue grafie, in quanto medico, se ne intende.
Ierzese, già medico di famiglia e fisiatra, 73 anni, un passato politico come sindaco del suo paese d’origine negli anni Ottanta e come consigliere comunale a Cagliari per buona parte degli anni Novanta, nonché come assessore provinciale alla Pubblica Istruzione, una smania per la ricerca documentaria e per l’antropologia criminale sviluppate in parallelo con la sua lunga attività negli ambulatori e in alcune brevi esperienze (presso i Tribunali di Cagliari e Lanusei) come consulente in medicina legale.
«Da medico mi ha sempre incuriosito il percorso patologico del paziente – racconta –, qual è lo sviluppo che da una situazione di affezione porta alla morte o alla guarigione. Uno specialista, qualunque sia il suo campo, ha il dovere di indagare quanto più dettagliatamente possibile ciò che ha davanti, e questa indagine deve necessariamente essere svolta a livello viscerale, molecolare; la funzione a cui è chiamato lo storico è esattamente la stessa. Troppi avverbi, troppi probabilmente, forse, poche salde certezze: chi fa ricerca deve essere in una botte di ferro! Il mio percorso di ricercatore e di assiduo frequentatore degli archivi (di Stato a Cagliari e Diocesano a Lanusei in primis) si è evoluto soprattutto sotto questa spinta (e lo sprone di nomi tutt’altro che marginali nel panorama saggistico sardo, quali Bruno Anatra e Giancarlo Sorgia, n.d.r.): la letteratura storica che parlava delle nostre origini e delle nostre piccole comunità necessitava di una revisione, andava nuovamente esaminata attraverso la lente delle carte, che spesso rivelano fatti che rispetto a testi considerati oramai sacri e incontrovertibili, assumono una dimensione totalmente opposta. Uno dei tanti emblemi fu quando lavorai alla prima stesura del saggio su Ulassai e mi accorsi, dopo nemmeno una settimana, che le informazioni da cui partii, quelle fornite dall’Angius, erano incongruenti: sul campo ebbi subito modo di ravvisare, ad esempio, la presenza di alcune emergenze archeologiche che lo studioso nemmeno citava. Insomma, se non si tratta di riscrivere del tutto la storia, quantomeno si ha il dovere di essere deontologicamente ed eticamente analitici».
E di analisi, negli anni, ne sono state fatte tante: dalle monografie su Jerzu e Ulassai (da cui provenivano i bisnonni), ai saggi realizzati sulle fitte testimonianze fornite dalle carte della Real Udienza, gli errori giudiziari e i compaesani dimenticati: «Una su tutti, Battistina Carta, della quale per prima mi parlò il compianto Peppino Fiori all’inizio degli anni Duemila. Una donna coraggiosissima, da annoverare sicuramente nelle fila dei partigiani ierzesi che di distinsero al Nord (come Salvatore Melis, perito a Torino nel tentativo di difendere il suocero, uno dei capi della Resistenza cittadina, o come Francesco Salis, alias Ulisse, a cui è stata di recente dedicata una piazza del centro storico), vedova della Grande Guerra, che sposò in seconde nozze un boemo, conosciuto a Jerzu, col quale prima si spostò a Praga dove sopravvisse alle persecuzioni di Heydrich e degli stessi italiani passati alle SS, poi tornò al paese natale, guardata a vista perché considerata una spia e costretta persino agli arresti domiciliari. E poi le vicende dei tantissimi soldati, martiri delle due Guerre e degli innumerevoli conflitti tra queste (Etiopia, Spagna, Grecia, dove l’esercito italiano scrisse una vergognosa pagina della sua storia, perpetrando un’autentica Marzabotto ellenica, sconosciuta ai più), che resistono anch’esse, indelebili, sulla stoica cellulosa dei fogli matricolari».
Ma le carte sono tante e solo di recente, dopo un lungo stop dovuto all’emergenza epidemiologica, gli archivi hanno potuto riaprire: «Sono in ultimazione I cipressi di San Vincenzo, una particolare analisi di duecento monumenti funebri del cimitero di Jerzu, corredato dalle splendide immagini di Renato D’Ascanio, nonché un altro studio sul territorio che verrà presentato nel 2022, in occasione del 250° anniversario dell’istituzione da parte del governo sabaudo dei consigli comunitativi (1772) e nel quale confluiranno i due saggi, Jerzesi: mille vite, una storia e Storia dell’amministrazione civica di Jerzu dal 1400 in poi. Questi volumi sono in dirittura d’arrivo, ma non vedo l’ora di tornare nei locali di via Gallura per dedicarmi a Morti di fame, un ideale ritorno alla medicina con l’esame delle carestie e delle epidemie dal Settecento in poi».

Felicemente all’aperto
di Fabiana Carta.
In questa storia ci sono tre elementi principali: una figlia, il desiderio di un ritmo lento, l’amore per gli animali
Pamela Balloi, quarantunenne di Lanusei, ha sempre vissuto per lavorare, come si suol dire. Per dieci anni ha lavorato in un salumificio e per altri dieci anni ha fatto la barista, con tutto quello che ne consegue: turni di lavoro massacranti, giornate che trascorrono veloci e frenetiche. «Io e mio marito siamo due stacanovisti, per noi esisteva solo il lavoro, al quale dedicavamo anche 16 ore al giorno», mi confessa.
A un certo punto la svolta, arriva una figlia: «Ha cambiato completamente la mia prospettiva di visione del lavoro, invertendo le priorità». Quel modo di vivere non poteva più conciliarsi con una figlia e il suo vedersi mamma, per questo entrambi sentono la necessità di pensare a un lavoro che non occupasse tutta la giornata, un lavoro da poter gestire in autonomia.
L’idea, racconta, nasce durante una delle visite periodiche dalla pediatra. «Era il periodo dello svezzamento, la dottoressa mi disse che la bambina avrebbe potuto mangiare le uova, possibilmente senza pesticidi, un uovo buono per davvero!». Perché non provare ad allevare delle galline in modo naturale? Alla fine del 2018 si imbarcano in questa avventura, con qualche dubbio e qualche paura. «Per iniziare – racconta – abbiamo provato ad allevarne qualcuna a casa e poi abbiamo deciso di fare quest’esperimento più in grande, documentandoci tantissimo». La scelta accurata sul tipo di galline, le Livornesi bianche, è il primo passo. Sono qualitativamente migliori, galline ruspanti adatte all’allevamento all’aperto. Pamela ci tiene a precisare che all’aperto non vuole a terra. Allevarle all’aperto significa lasciarle fuori nei campi, libere: «Hanno uno spazio enorme dove possono razzolare, divertirsi. Lasciamo a disposizione della paglia e rametti che le aiutano a scaricare lo stress». Mi spiega che un grande gruppo di galline è come un gruppo di bambini, più sono e più tendono a litigare fra loro. «Per aiutarle a stare bene e non beccarsi a vicenda hanno a disposizione dei giocattoli, questo ci permette anche di non tagliare loro il becco, pratica utilizzata per renderle calme e tranquille e non farsi del male a vicenda. Non hanno nessun tipo di forzatura, compresa la luce: considerando che depongono in base ad essa, vuol dire che d’inverno produrranno un po’di meno. A livello commerciale implica qualche rinuncia, ma ben volentieri purché gli animali stiano bene».
Pamela, con l’appoggio costante di suo marito, ha iniziato a piccoli passi. Con ombrellone e banchetto proponeva le sue uova nei vari mercati e il riscontro positivo le ha dato la carica per continuare a investire e impegnarsi in questo progetto. «Ho capito che il problema del buon cibo se lo pongono tante persone, soprattutto noi mamme». Oggi la sensibilità verso argomenti quali gli allevamenti intensivi e il benessere animale è certamente maggiore di un tempo e la scelta verso il cibo migliore è più accurata. Lo step successivo è stato quello di riuscire a vendere il prodotto nei negozi. «Io e mio marito siamo cocciuti, abbiamo fatto delle ricerche, ci siamo buttati dentro un iter burocratico che pareva interminabile e siamo riusciti a ottenere l’autorizzazione ministeriale grazie alla quale possiamo vendere nei market. In meno di un anno abbiamo raggiunto un obiettivo importante, ne siamo orgogliosi e felici!». Un’azienda agricola fresca fresca, nei territori di Loceri, una vera e propria oasi che ospita due gruppi di galline, uno da 250 e l’altro da 400, nel rispetto totale di questi simpatici animali.
«Le galline mangiano ciò che trovano in natura, come vermetti e pietroline. Stanno tutto il giorno fuori e all’imbrunire rientrano da sole nel capanno, dove possono trovare l’acqua, il cibo – noi aggiungiamo solo granaglie (indispensabili per la loro salute) – e i loro posatoi». Una grande soddisfazione il loro piccolo centro di imballaggi, che presenta tutte le potenzialità e le autorizzazioni che può vantare un grosso centro con trentamila galline.
Chiedo a Pamela come vede il futuro della sua azienda nata da poco: «Io sono già contenta così, vedremo come andrà, ho ancora tante cose da imparare, è meglio fare un passo per volta. Credo che aumenterò leggermente il numero di galline, ma non di tanto perché non potrei né garantire loro lo spazio e le attenzioni di cui hanno bisogno, né assicurare ciò che sto offrendo in questo momento».
Dopo la chiacchierata con Pamela mi rendo conto di quante volte, nei suoi discorsi, sia saltata fuori la parola felicità. Verso la fine chiedo il nome scelto per questa azienda: Felicemente all’aperto, mi dice. Appunto.

Silvano Vargiu e le sue vite in movimento
di Alessandra Secci.
Ci siamo chiesti in queste lunghe settimane, tante volte, prima e dopo il lockdown, quanti di noi avessero preso questo bislacco 2020 come l’occasione giusta per riflettere sulla propria vita, per cogliere al balzo l’opportunità di cambiarla, per seguire finalmente l’istinto.
Il 2020 di Silvano Vargiu è arrivato invece 25 anni fa: nel novembre 1995, al suo ultimo anno di superiori, partecipa a un laboratorio teatrale che Francesca Mastio, insegnante di lettere, organizza presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Lanusei, in coordinamento con una compagnia teatrale emiliana. È la svolta: da un percorso già in parte tracciato per frequentare Architettura a Roma – per la quale aveva peraltro sostenuto preventivamente l’esame di ammissione – Silvano resta sempre nella capitale, ma decide di dedicarsi a Lettere, indirizzo spettacolo: «L’esperienza di quell’anno scolastico cambiò completamente le mie prospettive – racconta – ma permase in me un profondo pragmatismo, un intimo senso del concreto che mi contraddistingue tuttora. Decisi di non scegliere l’Accademia d’arte drammatica, optando per Lettere col proposito di ampliare la mia cultura, e mi ritrovai in un ambiente universitario, quello romano, stimolante e fervidissimo.
Grazie a Clelia Falletti Cruciani, che ho avuto la fortuna di avere come docente, il mio interesse venne subito catturato dal cosiddetto terzo teatro, di cui Jerzy Grotowski ed Eugenio Barba sono tra i numi tutelari: un teatro più essenziale, naturale, intimista, che indaga profondamente il rapporto dell’interprete col suo stesso animo attoriale e che ben si presta ai laboratori che ho iniziato a tenere sin dalla fine degli anni Novanta, quando subito dopo la laurea decisi di rientrare in Sardegna, e su di lei (e su di me) scommettere. E direi che è andata bene: da allora, corsi annuali, laboratori propriamente detti, saggi, hanno contrassegnato la mia crescita personale e professionale; hanno coinvolto tutte le fasce d’età e, relativamente alla scuola, tutti i gradi d’istruzione, dai bambini delle materne sino all’Università della Terza Età. Negli istituti scolastici gran parte della volontà di adesione è demandata all’iniziativa personale degli insegnanti (come d’altronde la professoressa Mastio ai miei tempi) e – nonostante la burocrazia complichi sempre le cose, specie negli ultimi anni – con l’associazione Cantieri d’Arte Teatro La Chimera (fondata nell’ormai lontano 2007 con l’amico lulese Antonio Marras, con la quale avemmo peraltro modo di occuparci dell’organizzazione de Su Battileddu, il Carnevale tradizionale di Lula), grazie anche al progetto triennale Tutti a Iscola, nei nostri Cantieri d’Arte, abbiamo sublimato i laboratori annuali con gli studenti non nei consueti saggi teatrali di fine anno, bensì in cortometraggi, tutti realizzati col preziosissimo ausilio di Francesco Manca e disponibili su Youtube: da La Lezione, I giorni del Giudizio allo spassosissimo La mortadella, con gli alunni della Scuola Primaria di Ilbono.
Questo è stato in realtà il naturale sbocco, l’istintiva propensione degli ultimi sei anni, in cui è stata preponderante la formazione prettamente cinematografica: grazie alla mediazione di Michael Margotta, allievo di Lee Strasberg e membro attivissimo dell’Actor’s Studio di New York, del quale ho seguito molti seminari, ho approfondito quell’importantissima duplicità tra teatro e cinema, che fin troppe volte viene sottovalutata, e ora avrò presto l’occasione di cimentarmi in un film di Gianluca Medas che a breve riprenderà in mano dopo il lungo periodo di chiusura».
E aggiunge: «L’emergenza pandemica ha rappresentato una brusca frenata anche per il nostro settore, che è stato uno dei più colpiti: la programmazione non è facile e la situazione odierna è ancora sbilanciata, anche tenendo conto del fatto che vi siano poche possibilità per il finanziamento pubblico, se non quello previsto dalla legge Regionale n.56 del 1990, sui contributi alle attività dello spettacolo, che di fatto però taglia le realtà giovani. In questo, grande responsabilità dobbiamo addossarcela noi, e a livello sindacale solo ora, dopo tutte le criticità acutizzate dal Covid, si è aperto un vero dibattito sulla questione, e chissà che il confronto non possa presto raggiungere livelli normativi e tutelativi simili a quelli vigenti in altri paesi europei».
L’anelito per il futuro è in parte collegabile a quest’ultimo concetto: mi piacerebbe potesse esserci nel tempo una maggiore sensibilità verso il nostro lavoro da parte delle istituzioni, perchè l’esigenza del teatro traspare, è palpabile, soprattutto in zone come quella, meravigliosa, da cui provengo: sarebbe bellissimo se Lanusei, il mio nido, da cui mi alzo in volo e a cui torno, divenisse definitivamente il fulcro stabile delle mie passioni, un centro culturale di alto livello; anche quest’anno, riproporremo tra luglio e settembre la consueta rassegna Storie in movimento, giunta ormai alla settima edizione, e ripartiremo con grandi auspici dopo l’estate con la gestione del prestigioso Teatro Tonio Dei.
Continuità, come insegna il grande Grotowski: mai fermarsi, spingersi sempre oltre.

Il dolce sapore delle sfide
di Augusta Cabras.
Se per molti il 2001 fa rima con Odissea nello spazio, per Massimo Pusole e Antonio Incollu quell’anno segna il principio di un’avventura che ancora oggi continua.
Tutto inizia di fronte al mare di Santa Maria Navarrese, di fronte alle barche che di anno in anno ormeggiano sempre più numerose nel porticciolo turistico, inaugurato solo qualche anno prima con un enorme carico di aspettative e speranze per lo sviluppo economico del territorio. Nel complesso del piccolo porto si presenta ai turisti e non solo, anche un piccolo chiosco bar, in cui Antonio aveva lavorato la stagione precedente, assaporando il piacere di un lavoro vista mare e a contatto con persone provenienti da tante parti del mondo. Massimo nel frattempo aveva già mostrato interesse per la gestione della struttura, fin quando, nel 2001, entrambi hanno la possibilità di prenderla in gestione e di iniziare a progettare un locale che diventi il punto di riferimento per la gente del posto e per i tanti viaggiatori che scelgono Santa Maria Navarrese per le proprie vacanze.
Il primo è un anno di prova che i due soci superano brillantemente. L’entusiasmo sale, l’energia da investire è tanta e insieme, ciascuno con le proprie qualità, continuano a credere in questa sfida che porta molte soddisfazioni. I clienti si affezionano, il locale si rinnova ancora nel servizio e negli arredi e la sfida è sempre in divenire. Poi arrivano gli anni della crisi economica che attraversa tutta l’Italia, facendo sentire il fiato pesante su tutte le categorie di lavoratori. Ma si sa, dietro ogni crisi si nasconde il germoglio di una nuova ripartenza. Così, Massimo e Antonio, nel 2009, messe insieme le idee, decidono di acquistare la storica pasticceria baunese messa in vendita dagli storici proprietari. Acquistano lo stabile, i macchinari e le attrezzature, senza però poter contare sulla collaborazione delle persone che ci lavorano da anni. Anche il personale quindi viene rinnovato e, con la presenza di Massimo che ha una predilezione per la pasticceria, la società Navarmare inizia una nuova avventura.
L’impegno raddoppia, il Bar del Porto e la Pasticceria Baunese insieme, richiedono ulteriore energia, impegno e competenza gestionale che ai due compagni di sfida pare non mancare. «Abbiamo sempre avuto un principio che guida tutto quello che facciamo: garantire l’alta qualità dei servizi e dei prodotti. Questo richiede sicuramente uno sforzo maggiore, ma alla fine ripaga», spiega Antonio. Ed ecco allora la scelta dei fornitori e delle materie prime selezionate, la riscoperta dei sapori della tradizione, come la preparazione de su confettu, dolce tipico del matrimonio baunese e lo sguardo attento anche alla clientela internazionale. Ma la pasticceria, gioiellino nelle mani di Massimo, ha in potenza una nuova storia che progressivamente viene scritta. Tra i vari macchinari per preparare creme, sfoglie, glasse e biscotti, in un angolo e ancora in ottimo stato perché inutilizzata per molto tempo, c’è una macchina per fare il gelato. Anni prima di iniziare il suo lavoro al Bar del Porto, Antonio aveva lavorato in una gelateria e il ricordo di quel tempo e di quel lavoro, insieme all’idea di poter preparare personalmente i gelati, riaccende in lui una scintilla. Quella macchina viene spostata al Bar del Porto per essere complice delle prime sperimentazioni di Antonio, il quale, intuendone le potenzialità, inizia a formarsi in giro per l’Italia con Pino Scaringella, Maestro Gelatiere e consulente del gelato da oltre 40 anni. «Ho fatto il percorso inverso della maggior parte dei gelatai – spiega Antonio –. Sono partito dall’utilizzo dei preparati, nelle prime prove, per poi arrivare a un prodotto artigianale, fatto con prodotti locali, dalla frutta allo yogurt, dagli agrumi al latte di capra». Dopo le prime sperimentazioni e la formazione specifica, al Bar del Porto, Massimo e Antonio iniziano a far gustare ottimi gelati e i clienti ne apprezzano fin da subito la qualità e la bontà. Quella prima macchina per fare il gelato viene sostituita con una più grande e poi con un’altra più grande ancora, segno evidente dell’apprezzamento riservato ai prodotti. Visto il riscontro positivo, i due soci pensano che un altro passo, quasi naturale, sia quello di aprire una gelateria a Baunei, diventato nel frattempo uno dei luoghi più amati dai vacanzieri. Passa ancora qualche anno, utile a capire meglio il mercato, a scegliere il punto migliore o più adatto per aprire, e nell’estate del 2016, al km 155 della Via Orientale Sarda, si apre la saracinesca sotto la scritta Gelateria Timasù. Alcuni sospettano che nel nome ci sia un errore del grafico, altri sono certi che la piccola Lucrezia, figlia di Antonio e di sua moglie Mercedes, abbia suggerito il nome. Nessuna delle due supposizioni corrisponde alla realtà. Quel nome, un po’ distorto, che richiama il dolce tiramisù, in realtà è il modo simpatico in cui la nonna di Antonio, particolarmente golosa, amava richiedere la sua porzione di gelato al tiramisù. Un ricordo che lega le generazioni, che fa sorridere anche chi non ne conosce l’origine, ma che ormai oggi è diventato un marchio di qualità, legato in particolare all’utilizzo del latte di capra di Baunei che conferisce al gelato una cremosità e un sapore straordinario.
Così Massimo e Antonio, in vent’anni di sodalizio, con coraggio e determinazione, sono riusciti ad addolcire momenti della vita di tantissime persone, ormai affezionate ai cappuccini sorseggiati di fronte a un cielo che ogni istante regala i suoi colori al mare, agli ottimi dolci e ai gelati che sono un piacere per la vista e il palato. Semplicemente irresistibili.

Profumati di mirto
di Claudia Carta.
Prendi una pianta di mirto. Guardala. Ascoltala. Toccala. Ti regalerà le bacche. Le lascerà cadere nelle tue mani. Saranno il tuo tesoro più caro. Il nettare che ne verrà fuori, sarà delizia e balsamo, frutto sublime che ripagherà ogni fatica. È lo spirito dell’azienda biologica jerzese Mirteto 84
Le piante vanno accarezzate. Ne va accarezzato il frutto.
Filosofia dell’amore? Anche, perché no. Ma principalmente una missione. Quella di chi la campagna la vive, la rispetta, la cura. Perché sa che da questo dare scaturirà un ricevere.
Un amore che porta frutto e lo porta in abbondanza. Profumi e sapori intensi, ma soavi al tempo stesso. Decisi e avvolgenti. Freschi, ghiacciati, per l’estate più calda. Glassati e caramellati per una naturale voglia di dolcezza.
Lo direste voi che stiamo parlando di mirto? Mangio mirto e campo cent’anni. È da sempre il motto dell’azienda biologica jerzese di Ignazio Locci e Sabrina Orrù, Mirteto 84, una giovane coppia che con la terra ha fatto una scommessa: quella di realizzare una produzione che fosse interamente naturale, senza l’impiego di fitofarmaci, diserbanti o additivi chimici.
Attenzione. Mangio mirto. Non, bevo mirto. Via dall’immaginario collettivo, per un momento, l’idea del digestivo da sorseggiare dopo il caffè in un tranquillo pomeriggio ogliastrino. Qui parliamo di prodotti rigorosamente analcolici che tutti, anche i più piccoli, possono gustare con ricette diverse, da inventare e da cambiare, perché non c’è limite alla fantasia e alla creatività sulla tavola.
Lo scenario. Pelau, regno di vigneti da sempre. Località Sa Spadula. Qui un ettaro di terra raccoglie il respiro di 1700 piantine. L’idea nasce nel 2013. Ignazio e Sabrina non si fermano a quello che è solo un pensiero e piantano subito ben 1021 mirti, incoraggiati e supportati anche da Manfredi Cannas: è suo il terreno concesso in affitto ai giovani sposi. Quando zio Manfredi verrà a mancare, all’età di 84 anni, la coppia di imprenditori jerzesi lo omaggia inserendo nel nome della loro azienda un numero che significa dedizione e riconoscenza.
Due anni e, nel 2015, quello che era un progetto diventa realtà ufficiale. Sa Spadula profuma di mirto, non solo di vino. Da allora, ogni giorno reca con sé una storia nuova. E sono le piante a tesserne le trame, fra sole e pioggia, fra maestrale e scirocco. «Le piante sono come i figli – sorridono –: ti fanno disperare ma poi, quando mostrano il frutto del tuo lavoro, tutto passa!». Un lavoro certosino, costante, che richiede sacrificio e fatica. Ma Ignazio, che sa bene cosa significa lavorare la terra, è guidato da tenacia e determinazione. Sa di realizzare qualcosa di importante, di singolare, sa che può concretizzare davvero la sua idea in mille sfumature e che può imprimere sopra la certificazione di genuinità e autenticità.
Artigiano del mirto. Se fosse un marchio, sarebbe: realizzato a mano. E il marchio c’è, eccome. Vero, come le mani che raccolgono le bacche: «Ci si impiega un po’ di più – fa notare – ma il frutto viene preservato, la bacca non subisce danni e stress, non si altera e si conserva bene. La prima fase, quella della raccolta, fatta interamente a mano, è molto bella, salutare e rilassante. Successivamente, in laboratorio, hanno inizio lavorazione e trasformazione».
Anche la preparazione e il confezionamento avvengono sul posto. Cortissima la filiera. Grande l’orgoglio. Sublime il risultato.
La glassa di mirto. Su maistu. «È studiata per osare in cucina – dicono quasi strizzando l’occhio al buongustaio e a chi non resiste alla tentazione di un piatto diverso –. Non solo si può utilizzare per insaporire la selvaggina ma, anche formaggi, salumi, verdure e condire insalate». Il consiglio? «Ottima con il capriolo».
La composta di mirto, priva di conservanti e coloranti: «Ottima da gustare al mattino sul pane, sulle fette biscottate e, in abbinamento con i formaggi, è ideale anche per guarnire sebadas e farcire crêpes. Il suo retrogusto leggermente tannico la rende molto apprezzata a chi non ama la confettura troppo dolce».
C’è anche lo sciroppo. Nemus. Un nome che a Jerzu, ma ormai ovunque in Italia, è divenuto assai familiare. «È ottimo accompagnato ai dolci secchi, ai dessert e ai dolci al cucchiaio, per via della sua essenza corposa dal sapore intenso e persistente».
E ancora, il miele di mirto, il semifreddo, gli oli essenziali e, perché no, anche il mirto analcolico Nero di Pelau, per chi non vuole comunque negarsi il piacere di un buon digestivo o aperitivo dall’inconfondibile sentore, ma che ben si adatta anche come condimento per piatti a base di carne e pesce.
Il lavoro paga sempre. E la qualità pure. Non tardano ad arrivare nemmeno prestigiosi riconoscimenti, come quello di Sardinia Food Awards, l’Oscar delle eccellenze agroalimentari della Sardegna, conquistato nel 2018 per la categoria “Distillati e liquori”, o la significativa partecipazione a Mirtò, l’esclusiva fiera nella cornice spettacolare di Porto Cervo.
E poi c’è Anna, la piccola di casa, 13 anni, assaggiatrice ufficiale di tutti i prodotti e i preparati. Il suo gusto, la sua opinione, il suo riscontro sono fondamentali per testare quello che sarà il grado di apprezzamento fra i clienti, fra i quali figurano tanti suoi coetanei.
Ma con i ragazzi, l’equipe di Mirteto 84, ha un rapporto davvero speciale: le scolaresche vanno in visita all’azienda, ne seguono le fasi di produzione o di lavorazione, ne percepiscono la filosofia. Scoprono che il suo segreto vitale è nella naturalezza delle fasi, dalla coltivazione al prodotto finito. Imparano quell’amore e quel rispetto per ogni pianta, per ogni bacca, per ogni angolo di terra che solo sentendosi amata, può restituire bontà e salute, in un continuo circolo virtuoso.
Ignazio, Sabrina e Anna hanno iniziato dai campi pieni di sole del Pelau, dal verde di Sa Spadula, dal fiore di una pianta. Ma si sa, per fare tutto ci vuole un fiore. Di mirto.

Renato Muggiri e lo stato persistente di meraviglia
di Augusta Cabras.
Ha iniziato a muovere le dita su un pianoforte quando aveva circa dieci anni. Prima di allora Renato Muggiri si divertiva a suonare lo xilofono e le piccole tastiere messe a disposizione dal padre, grande appassionato di canto polifonico, dimostrando fin da piccolissimo una particolare predisposizione e una grande passione per la musica.
A Villagrande Strisaili Renato vive un’infanzia igienicamente perfetta, per dirla con De Gregori, amato da Muggiri insieme ai grandi cantautori italiani e ai gruppi rock statunitensi come i The Smashing Pumpkins, (per lui una delle maggiori fonti d’ispirazione), e gli Aerosmith.
Dalla quinta elementare segue con curiosità e interesse le lezioni di pianoforte del suo primo maestro, il professor Domenico Pellegrino, fino al tempo dell’adolescenza. E l’adolescenza, come capita a tanti se non a tutti, porta con sé una buona dose di scompiglio e la tendenza al deragliamento da sentieri canonici; regala interessi nuovi insieme a quello sguardo di sufficienza su quanto fatto fino a quel momento, compresa, nel caso di Renato, la musica al pianoforte, che smette di essere, ma solo per un po’, un interesse predominante.
Gli anni passano, nel frattempo Renato si diploma al Liceo Scientifico e insieme alla maggiore età arriva una nuova consapevolezza e un dominante desiderio: vivere solo di musica. «Ho avuto proprio un’illuminazione – racconta –, ho riscoperto la voglia di suonare, la necessità sempre più forte di studiare ancora. I miei genitori mi hanno permesso di iscrivermi al Conservatorio di Cagliari, non senza qualche perplessità data la mia incostanza e il mio percorso non perfettamente lineare. A quel punto ho preparato l’esame di ammissione e ho iniziato. È stato un percorso impegnativo e stimolante, sotto la guida di grandi maestri, come Francesca Carta e Romeo Scaccia».
Ma c’è un’esperienza che si rivela determinante nella vita e nel percorso artistico di Renato Muggiri: l’Erasmus a Cracovia. Sei mesi in Polonia per un nuovo inizio, con nuovi incontri, rinnovate possibilità e nuove collaborazioni: «Lì ho scoperto un altro mondo – prosegue –; ho frequentato un’Accademia di altissimo livello e mi sono accorto, che, nonostante questo, c’era spazio anche per me. Ho iniziato a dare una direzione al mio fare musica e questo mi ha permesso di liberarmi dalla paura di non farcela, di essere in ritardo, di essere troppo grande; mi sono liberato via via di zavorre inutili che appesantivano il mio cammino, la mia mente e il mio corpo, che mi impedivano di lasciare fluire le cose, cogliendone le possibilità e la bellezza».
Ed è privilegio degli artisti questo contatto costante con la bellezza, lo stato persistente di meraviglia, che rapisce nell’atto di dar forma, spazio e tempo alla musica, tra suono e silenzio, tra piani e forti, tra attesa e compimento. È un continuo comporre e sciogliere, tendere e allentare, battere e levare, in un gioco di armonie di fronte al quale si resta senza fiato. «Io continuo a provare stupore», dice Renato quando gli chiedo cosa provi nel momento in cui con il movimento delle sue dita fa nascere la musica. «Quando suono Chopin, Brahms, solo per citarne due, mi chiedo come sia possibile così tanta bellezza. Provo ogni volta una sensazione di incredulità e di stupore». E forse è proprio lo stupore, categoria fondamentale dello spirito, la chiave d’accesso al bello; ciò che permette, senza troppi sofismi di contattare la parte più intima e profonda dell’uomo e del mondo, lasciando una porta aperta verso l’altrove da dove alcune musiche paiono arrivare.
E una volta raggiunta questa consapevolezza è impossibile non condividerla con gli altri. «Ormai è la mia missione – ammette con un sorriso –. L’insegnamento della musica è parte fondamentale del mio lavoro. Voglio che altri, a partire dai bambini, possano fare esperienza della musica e della sua bellezza. Insegno che la musica apre ed emoziona; cerco di insegnare che c’è sempre un’altra possibilità».
Oltre a essere un insegnante, Muggiri è un compositore e ha all’attivo importanti collaborazioni con altri professionisti, in particolare con la cantante e attrice Gisella Vacca, la violinista Noemi Loi e la cantante Jessica Trudu. Tre artiste con le quali Renato Muggiri esplora ambiti musicali diversi, spaziando dal jazz al pop, dai ritmi latini alla musica contemporanea, dal blues al rock, senza dimenticare e abbandonare del tutto le radici classiche. Con loro porta nei palcoscenici sonorità originali, risultato di una ricerca continua, di un esercizio e di una passione costantemente alimentata.
Ho il piacere di ascoltare alcune composizioni per pianoforte e violino. Mi rivelano un respiro ampio, comunicano dinamicità e gioia. A occhi chiusi, le note trasportano la mente nello spazio, disegnano geometrie fluide e leggere, danzano raggiungendo vette sonore commoventi e accompagnano lentamente il respiro lasciando, alla fine, la sensazione che lascio un bel viaggio.
È certamente il potere delle stupore, vissuto, sperimentato e condiviso.

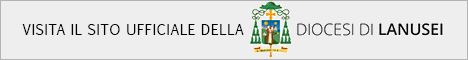







.png)


