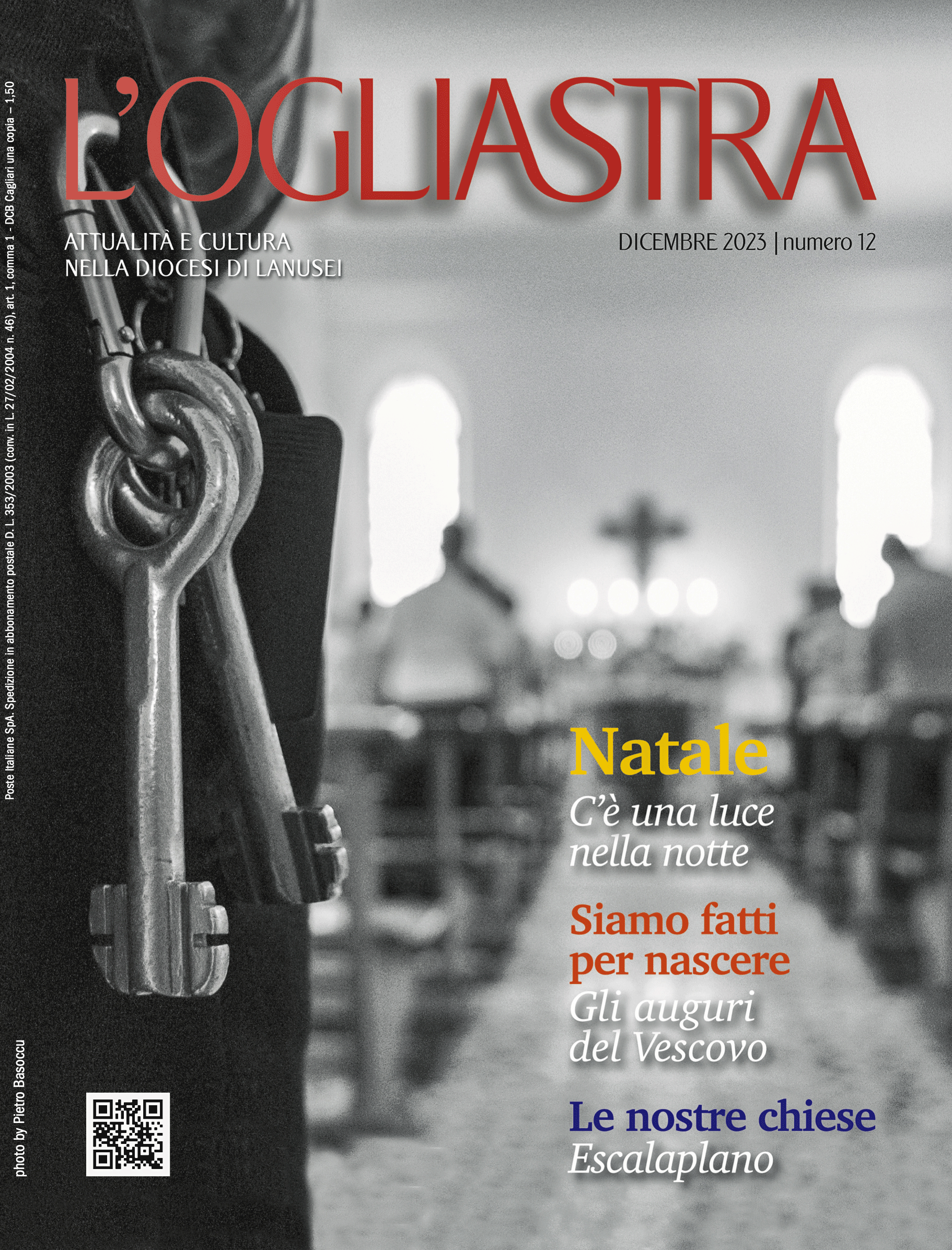Fatti

Giovani in Caritas: una risorsa straordinaria
di Augusta Cabras.
È una storia questa che smentisce il luogo comune che vorrebbe i giovani disinteressati, privi di entusiasmo ed energie, piegati su loro stessi e sui loro smartphone.
È una storia che racconta che serve occuparsi dei giovani e fare loro proposte valide per far nascere in loro il desiderio di amicizia, condivisione e servizio, anche ai poveri
Hanno iniziato la scorsa estate. Timidamente. Con il passo calmo e leggero. In modalità “esplorazione”, con l’atteggiamento tipico dei giovani, quello che oscilla tra il desiderio e la paura del nuovo, tra la tentazione di buttarsi nella mischia e la resistenza di chi sente il giudizio altrui (soprattutto quello degli adulti), sempre sopra la testa.
Hanno lasciato per un po’ il divertimento dei tuffi nel mare cristallino delle nostre coste e il calore della sabbia e hanno fatto un’esperienza nuova, «bellissima, dicono loro.
Sono i giovani della nostra diocesi, in particolare delle parrocchie di Tortolì e Arbatax, che hanno fatto (e alcuni di loro continuano ancora oggi) un’esperienza di volontariato, di condivisione e di servizio.
«Abbiamo avuto modo di conoscere da vicino il mondo del volontariato e della Caritas – raccontano con entusiasmo – attraverso attività, laboratori, giochi e nuove esperienze che probabilmente ricorderemo a lungo. Abbiamo toccato con mano l’accoglienza e lo sforzo che la Caritas fa per aiutare le persone in difficoltà, non solo economica. Sono stati importantissimi gli incontri con i testimoni che mettono a disposizione il loro tempo e la loro esperienza, per gli altri. L’ascolto dei racconti dei volontari ci hanno permesso di imparare, conoscere e comprendere il lavoro di chi, gratuitamente, si mette a disposizione degli altri e compie il bene. Abbiamo conosciuto le storie di Stefano e Antonella, tra i primi volontari della Comunità di Sant’Egidio, di Colomba, Cristina e Alessandra, tre delle tante musiciste del Gen Verde, e abbiamo imparato che il mondo si può migliorare, a piccoli passi, mettendosi in gioco».
E se la prima giornata si è caratterizzata per essere un misto di imbarazzo e paura, di parole dette tra i denti per il rischio rappresentato dalla troppa esposizione, nei giorni successivi, il ghiaccio si è rotto, la paura si è affievolita e l’imbarazzo ha lasciato spazio alla voglia di conoscere, sperimentare e condividere. «Per allentare la tensione, il gioco e l’attività pratica sono stati fondamentali. Le ore sono trascorse in allegria, tra una sfida e l’altra. Abbiamo imparato che siamo davvero tutti “nella stessa barca” e che insieme si possono fare cose belle e utili per gli altri. Questa esperienza è stata molto interessante e formativa perché ci ha permesso di conoscere nuove persone e fare nuove amicizie. Siamo così soddisfatti che lo consigliamo a tutti i giovani. Potremmo consigliare, a chi vorrebbe ma ha qualche dubbio e qualche resistenza, di non avere paura e di non lasciare troppo spazio all’imbarazzo, ma di buttarsi, di avere coraggio, di lasciare uscire le emozioni e di trasmetterle agli altri, di coinvolgere altri amici e di aprirsi con entusiasmo, in modo da poter vivere al meglio questa esperienza di volontariato e condivisione».
I giovani, quante risorse straordinarie!

Gli studenti del Classico e un sogno chiamato Grecia
IV A Liceo Classico Tortolì.
Il viaggio d’istruzione in Grecia dello scorso marzo è stato, per tutto il Classico di Tortolì, un’occasione unica per trovarci immersi nei luoghi più celebri della storia e della cultura greca classica, pietre miliari del nostro indirizzo
Era da molti anni che il nostro liceo non riusciva a portare a termine l’organizzazione di questa uscita, per via dei costi proibitivi e delle problematiche legate all’assenza di voli diretti dalla Sardegna. Quest’anno finalmente, affrontate e superate pervicacemente alcune difficoltà logistiche, la partenza – attesissima tanto dagli alunni quanto dai docenti – è stata fissata per il 9 marzo.
Mentre la data si avvicinava, l’entusiasmo era incredibilmente forte. Esclusi i giorni 9 e 13 marzo, trascorsi in viaggio, l’agenda prevedeva tre giorni con pernottamento in un hotel centrale ad Atene e la visita di una regione diversa per ciascun giorno.
Per l’intera durata del viaggio siamo stati accompagnati da una guida locale, Irene, che con un’ottima padronanza dell’italiano ci ha illustrato arte, storia e i tanti miti legati ai siti che abbiamo visitato. Il primo giorno ci ha guidati nel centro storico della città, attraverso le vie affollate del mercato, l’Agorà Romana, l’Acropoli. Passeggiando tra bancarelle, ristoranti tipici, venditori ambulanti e altre scolaresche, abbiamo percorso la via di San Paolo fino all’Acropoli, il monumentale santuario dell’antica polis. Prima di fare qualche gradino per ammirare il Partenone, in fase di manutenzione, e la bellezza femminile delle Cariatidi, si è aperto davanti ai nostri occhi uno splendido panorama della città. Durante la discesa, invece, abbiamo potuto osservare il teatro di Erode e il teatro di Dioniso, fino a ritornare nelle vie caotiche della città per il pranzo. Liberi nella scelta, ma consigliati dalla guida, abbiamo gustato alcune prelibatezze della cucina greca come il gyros, un piatto di carne cucinata in modo simile al kebab e accompagnata da verdure e salsa tzatziki.
Nel pomeriggio abbiamo visitato il Museo dell’Acropoli, la cui collezione presenta le opere celeberrime rinvenute sull’Acropoli, quali il Moscoforo o la Kore col peplo.
Il secondo giorno abbiamo affrontato un viaggio di circa due ore dall’Attica al sito di Delfi, nella montuosa Focide. Attraverso paesaggi naturali suggestivi e altri siti ben noti, come le città di Cheronea e Tebe, la guida ci ha intrattenuti con il racconto di miti ed eventi storici. Arrivati al sito, che sorge nei pressi di una piccola località sciistica, abbiamo visitato il Museo archeologico di Delfi, patrimonio dell’Unesco, con la sua collezione di statue, ceramiche e metalli di fondamentale importanza nella storia dell’arte greca antica: gli imponenti fratelli Cleobi e Bitone (Kouroi), che caddero in un sonno eterno dopo aver trainato il carro della madre, sacerdotessa di Era, al posto dei buoi; la sfinge di Naxos e l’auriga di Delfi. Percorrendo poi la Via Sacra – oggi un sentiero naturale che collega i vari elementi del sito – abbiamo apprezzato il teatro, l’agorà, i tesori delle città devote, il tempio di Apollo, in cui proprio la Pizia annunciava il responso dell’oracolo, e lo stadio.
Nel tardo pomeriggio siamo tornati ad Atene per una passeggiata a piazza Syntagma, la piazza più importante della città, dove abbiamo assistito al cambio della guardia presso la tomba del milite ignoto, davanti al Parlamento. La cerimonia spicca nella sua unicità per le uniformi tradizionali indossate dalle guardie e per il loro inconfondibile passo.
Il terzo giorno ci siamo diretti nella regione del Peloponneso, con un viaggio poco più breve ma non meno suggestivo, grazie alla vista delle diverse località marittime e all’attraversamento dell’Istmo di Corinto: qui abbiamo fatto una breve sosta per scattare qualche foto al celeberrimo Canale. Giunti in Argolide, abbiamo potuto ammirare il teatro di Epidauro, in ottimo stato di conservazione, e sperimentarne l’eccellente acustica ascoltando un antico canto in lingua greca intonato dalla guida. Abbiamo poi visitato la tomba di Atreo e l’antica città di Micene, passando per la maestosa Porta dei leoni e gli altri luoghi abitati un tempo da personaggi leggendari come i sovrani Agamennone e Clitemnestra. A pranzo ci siamo accomodati in un ristorante internazionale: graditissimo da molti e meno da altri, come un altro tipico piatto greco, il pastizio, molto simile alla nostra lasagna, realizzato con una pasta tubulare, carne trita, spezie e formaggio, ma senza sugo di pomodoro.
Abbiamo lasciato la Grecia il giorno seguente, stanchi, ma emozionati. È stata un’esperienza ricca, coinvolgente, utile a conoscerci oltre i soliti ritmi scolastici. Sull’aereo che ci ha riportato a casa, in tanti abbiamo continuato a pensare agli splendidi luoghi visitati, alle chiacchierate, alle risate, alle amicizie nate o consolidate. Speriamo di poter ripetere l’esperienza al più presto, sicuri che la Grecia ci regalerebbe ancora tante meraviglie.

Parrocchia: braccia e mani aperte
a cura di Filippo Corrias
Lo scorso 25 marzo, papa Francesco, incontrando il parroco e un gruppo di fedeli della parrocchia di Rho, ha rivolto loro un discorso sull’importanza e la bellezza della parrocchia, descrivendola anzitutto come «un corpo composto di tante membra, tutte al servizio le une delle altre e tutte animate dallo stesso amore: quello di Cristo e quando non è così, cade nella mondanità, cade nel clericalismo che è una cosa bruttissima. Ricordatevi sempre che è con la bellezza e la ricchezza di questa varietà e di questa comunione che voi portate Gesù al mondo: è questo il mezzo più potente con cui annunciate il Vangelo, prima ancora delle parole!».
La Parrocchia, secondo l’insegnamento di papa Francesco è un luogo dove camminare insieme seguendo Gesù Cristo, da qui l’invito, accorato, a «camminare insieme come fratelli e sorelle, perché la fratellanza rende le persone più libere e felici. Il mondo non finisce con noi stessi, per favore! La comunità non si fa davanti allo specchio, io e lo specchio, no! Camminare insieme, camminare con amore. L’amore tra voi sia sempre al primo posto. Amare significa “allargare la cerchia”, costruendo unità nella fiducia e nell’accoglienza, lavorando insieme e cercando sempre i punti in comune e le occasioni per fare comunità, piuttosto che i motivi di divisione».
La Parrocchia è una casa: «un luogo benedetto, dove si va per sentirsi amati. Chi bussa alla porta delle nostre chiese e dei nostri ambienti cerca spesso prima di tutto un sorriso accogliente, cerca braccia e mani aperte, occhi desiderosi di incontro e carichi di affetto. In una Parrocchia, tu bussi alla porta e, se non è l’ora, ti dicono: “Vattene, è finito l’orario”. La gente non si stanca di chiedere e di chiamare, e noi non dobbiamo stancarci di aprire le porte e le finestre. Se tu sei prete, è per questo; se tu sei nel circolo della Parrocchia, è per questo: per aprire porte, per aprire finestre, per ricevere sempre con un sorriso. E non dire “non è ora”. Apertura totale: braccia e mani aperte, occhi desiderosi di incontro e carichi di affetto. Questa è la pastorale di una parrocchia».
La parrocchia possiede una lunga storia e ha avuto dagli inizi un ruolo fondamentale nella vita dei cristiani e nello sviluppo e nell’opera pastorale della Chiesa; già negli scritti di San Paolo se ne può intravvedere la prima intuizione.
La parrocchia si pone come risposta a una esigenza pastorale precisa, portare il Vangelo vicino al Popolo attraverso l’annuncio della fede e la celebrazione dei sacramenti. La stessa etimologia del termine rende comprensibile il senso dell’istituzione: la parrocchia è una casa in mezzo alle case e risponde alla logica dell’Incarnazione di Gesù Cristo, vivo e operante nella comunità umana. Essa, quindi, visivamente rappresentata dall’edificio di culto, è segno della presenza permanente del Signore Risorto in mezzo al suo Popolo.
Dall’Istruzione “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”, Congregazione per il clero, 27-6-2020.
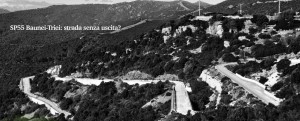
Ricomincio da quattro (chilometri)
di Claudia Carta.
C’era una volta la strada provinciale 55 che collega Baunei a Triei. In realtà non c’è mai stata, dal momento che trattasi di arteria viaria che, ahinoi, è da ormai trent’anni entrata di diritto nell’albo nazionale delle incompiute.
Quattro chilometri. Come dire un tiro di schioppo. Tanto distano fra loro Triei e Baunei, se solo li si potesse percorrere. 4 contro 15 (l’attuale distanza che separa i due centri ogliastrini transitando sulla Statale 125. Tempo: 7 minuti contro i 15 necessari oggi.
Ma qui non si tratta solo di minuti e percorsi ridotti. Qui si tratta di continuità territoriale, di progetti e sviluppo comune, di interscambio di servizi, di ulteriore sinergia fra tessuti sociali di due comunità contigue.
Anni Settanta, alias in principio fu il progetto. Anni Ottanta e Novanta o dei primi interventi edilizi. Tra rimpalli amministrativi, beghe fra comuni e provincia, mancanza di finanziamenti adeguati tutto tace, con buona pace degli interessi di baunesi e triesini.
E adesso? E domani?
Ne abbiamo parlato con i sindaci di Baunei e Triei, rispettivamente Stefano Monni e Anna Assunta Chironi.
L’intervista integrale la trovate sul numero 4 de L’Ogliastra, aprile 2023
“Politica, quando e dove ti sei persa?”
di Franco Colomo.
Perché la Chiesa deve occuparsi di politica? «Perché non può farne a meno e perché occorre ritrovare la possibilità di parlarsi e di ascoltare». Nelle parole del Vescovo Antonello il senso dell’evento vissuto al Teatro San Giuseppe di Nuoro lo scorso 31 marzo, dal significativo titolo “Politica: quando e dove ti sei persa?”.
Di politica si può e si deve parlare, e lo si è fatto con parole alte grazie al contributo di sette big della politica sarda e nazionale: Pietrino Soddu, Antonello Soro, Angelo Rojch, Antonello Cabras, Renato Soru, Carmelo Porcu e Beppe Pisanu. Sono stati presidenti della Regione, ministri e parlamentari. È la voce dell’esperienza, che richiama alla necessità di ritrovare anima, cuore e mente, di riscoprire quell’impegno inteso come servizio e non come ricerca del potere fine a se stesso, nella migliore tradizione del cattolicesimo democratico, come ha ricordato Angelo Rojch.
Così Pietrino Soddu: «Dobbiamo trovare il modo – ha detto il sette volte presidente della Regione – per andare uniti all’individuazione di un obiettivo che stiamo inseguendo da tanto tempo», e cioè «un nuovo patto con lo Stato che dia alla Sardegna più sovranità».
Non è mancata l’analisi di una crisi che viene da lontano e che ha portato nei cittadini disaffezione e disinteresse.
Antonello Soro ha spinto sul concetto di partecipazione: «È importante nell’interesse generale, nello spirito che la Costituzione italiana assegna ai partiti, ritrovare il canale originario, quello dei cittadini che sono chiamati a decidere le sorti del Paese partecipando attivamente».
In Sardegna, per l’ex presidente della Regione Rojch, manca oggi «la passione autonomistica, quella civile e politica» al contrario di quando, combattendo il graduale disimpegno dello Stato nell’Isola, diversi furono i successi e le conquiste per il Nuorese. «La nostra non era l’età dell’oro – ha concluso – ma era l’età dell’impegno: ce la mettevamo tutta e non da soli, ma con la collaborazione di tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione, sindacati, forze sociali».
Antonello Cabras ha allargato l’orizzonte a una crisi politica che coinvolge l’intero occidente ricco. Ha poi colto l’invito di Pietrino Soddu: «Quello della sovranità – ha detto l’ex presidente della Regione e senatore – è un terreno che dobbiamo esplorare, analizzare, ma non trascuriamo il tema che la crisi della democrazia nasce dal fatto che le persone si sentono aggredite e non trovano chi può difenderle».
Ma è soprattutto lo sguardo al futuro che ha colpito la platea, e per l’Isola significa ripartire dal mondo che si sta disegnando, quello che ha e avrà al centro valori come la conoscenza e la difesa del creato, come ha sottolineato Renato Soru: «Il tempo più bello deve venire se lo vogliamo cogliere – ha concluso –, da creatori, non solo da consumatori». L’ex governatore ha poi sorpreso tutti lasciando intendere come il suo impegno “sul campo” non sia ancora finito.
Carmelo Porcu ha concentrato il suo sguardo sul nuovo millennio, ricordando come fu Giovanni Paolo II a guidarci nel varcare quella soglia. Un tempo però segnato da attentati, crisi economica, pandemia e ora la guerra: «Prima ancora di sapere o di chiederci dov’è la politica dobbiamo chiederci dov’è finito l’uomo – ha affermato l’ex deputato –. Non è possibile che noi assistiamo a questo processo di vittoria del nichilismo in salsa moderna, in cui i valori vengono messi in discussione, in una società dove regna purtroppo la legge del più forte, dove finisce anche la capacità di chiamarsi fratelli».
In conclusione non è mancato un accenno all’attualità, al Ddl Calderoli sull’autonomia differenziata: «Per la Lega – ha detto Beppe Pisanu, incalzato dal moderatore Giacomo Mameli – non è che il nuovo nome di quello che prima hanno chiamato secessione e poi devolution». L’ex ministro, già capo della segreteria politica Dc con Zaccagnini, ha spiegato che quando la politica arretra, a prendere il suo posto è la burocrazia, il mercato, i poteri forti quando non occulti. Per Pisanu però, la politica può recuperare il ruolo che le compete, e lo ha detto pensando al nuovo protagonismo delle donne, dei giovani e dei lavoratori.
A tirare le fila è stato il Vescovo, dopo aver smontato una a una le obiezioni sollevate da qualcuno alla vigilia dell’incontro: «Abbiamo bisogno di persone che abbiano idee, non di propaganda o ideologia, che studino e si formino. Occorre evitare che la democrazia si trasformi in personalismo – ha aggiunto monsignor Mura –, ed è necessario selezionare meglio la classe politica dando la possibilità a tutti di giocarsi la propria passione, meno opportunismi e più idee, più discernimento in vista del bene comune». Il messaggio finale è per i docenti di religione presenti: «Educate i ragazzi ad avere passione politica», l’invito.
E questo evento non è che un primo passo, una risposta, tra l’altro, alle sollecitazioni arrivate nell’ambito dell’ultimo convegno ecclesiale quando dai gruppi sinodali era emersa proprio la richiesta che la Chiesa diocesana promuovesse una scuola di formazione politica.

La venerazione della Madonna delle Grazie a Ilbono
di Maria Gina Balzano.
La chiesa parrocchiale di Ilbono, intitolata a San Giovanni Battista e risalente al 1600, custodisce la devozione e il simulacro della Madonna delle Grazie da oltre 400 anni.
La festa di colei che venne dal mare viene celebrata ogni anno la prima domenica di luglio.
La tradizione tramanda che, nelle spiagge di Cea, località marina tra Bari Sardo e Tortolì, a testimonianza del mistero della presenza premurosa di Maria verso coloro che sono sballottati nella tempesta della vita senza soccorso, sia approdata una cassa, proveniente da un naufragio, contenente una statua lignea rappresentante la Madonna con in braccio Gesù Bambino.
In quel luogo si trovavano molti agricoltori impegnati nella mietitura del grano, provenienti da tutta l’Ogliastra. Grande fu lo stupore all’apertura del prezioso scrigno nel vedere la bellissima statua splendente alla luce del sole. La decisione su chi di loro sarebbe dovuto diventare proprietario di quel tesoro venne lasciata agli anziani presenti. Dopo essersi consultati, proposero di adagiare la preziosa cassa su un carro trainato da buoi non ancora domati, per evitare di percorrere strade già conosciute, e lasciando alla Divina Provvidenza la destinazione finale.
Fu così che il carro con il suo prezioso carico partì per il suo primo pellegrinaggio, scortato dagli agricoltori che, segretamente nel loro cuore, speravano si fermasse nel paese di residenza di ciascuno di loro. Tanti furono gli incroci che il carro trainato dai buoi escluse per imboccare sempre la strada che portava ad Ilbono, nonostante venissero incitati a proseguire oltre.
Arrivato a Ilbono il carro entrò in paese e con decisione i buoi imboccarono la strada che conduceva alla chiesa parrocchiale dove la Madonna col Bambino si fermò per sempre, diventando portatrice della bellezza divina che sa dare senso al quotidiano, mantenendo viva la speranza nella vita di innumerevoli generazioni, arricchendone la sensibilità, l’umanità e la testimonianza di fede. Subito fu chiamata Madonna delle Grazie.
Durante i secoli i fedeli devoti hanno donato a lei quanto di più bello e di più caro avevano in casa come ringraziamento per le grazie ricevute e che ancora oggi vengono richieste e accolte. Ex voto che raccontano la spiritualità e l’animo degli abitanti di Ilbono e dei tanti pellegrini che ancora oggi vengono a venerarla, le prove da loro subite e la forza d’animo che con l’aiuto della sua grazia ha permesso loro di rialzarsi e ripartire nel cammino della vita.
La festa della Madonna viene preceduta da una novena di intensa preghiera. Il sabato che precede la festa tanto attesa, alcune donne del paese si occupano della vestizione del simulacro della Madonna con il costume tradizionale di Ilbono e di coprirla da capo a piedi con su mantu. Anche il Bambino Gesù che la Madonna tiene in braccio viene vestito con un abitino ricamato a mano.
Sul grembiule che la copre fino ai piedi vengono sistemati in gran numero di gioielli, chiaro segno della sua carità e testimonianza del profondo legame che unisce la popolazione alla Madre di Dio.
La sera, la Santa Messa della vigilia è gremita di fedeli e di molti ospiti che vengono da diverse parti dell’Ogliastra per sciogliere i voti fatti durante l’anno.
Nella giornata di domenica, gli Ilbonesi usano addobbare, lungo il percorso della processione, i balconi con fiori e i ricami più preziosi dei loro corredi. In serata, il corteo con il simulacro della Vergine ricoperta di gioielli si snoda lungo le vie del paese, con il carro che il comitato ha adornato dei fiori più belli e dei rami di palma. La toccante commozione è sempre la stessa, ondeggia sulla folla dei protetti di colei che accoglie da secoli il pianto di ogni creatura.
Aprono la processione gli stendardi delle associazioni presenti in parrocchia con le donne che intonano l’Ave Maria in sardo. La processione è arricchita dai colori di donne, uomini, giovani e bambini che per l’occasione indossano il costume tradizionale. Ma anche di gruppi folk provenienti da diversi paesi della Sardegna. A tutti loro viene consegnato unu palini, un cesto, coperto da ricami e merletti con all’interno le torte donate dagli Ilbonesi, sempre per grazia ricevuta, che al termine della Santa Messa verranno distribuite a tutti i presenti.
Il percorso vivo e festante della moltitudine di fedeli è alternato da inni religiosi che mettono a contatto con la fede di un popolo, e dal suono delle launeddas, dalle fisarmoniche e della banda
musicale. Antica anche l’usanza di far accompagnare la festa da cavalieri e fucilieri che con i loro spari anticipano il percorso del corteo. La Messa solenne in parrocchia viene animata dai canti che contribuiscono a creare un’atmosfera di intensa spiritualità, a conclusione della quale vengono intonati is goccios alla Madonna, antiche lodi scritte da un suo devoto, Francesco Lai Piroddi, nell’anno 1909.
La profonda religiosità si alterna alla festa laica che viene organizzata da is obreris che con un gesto d’amore e di sacrificio si impegnano per il proprio paese e per la comunità.

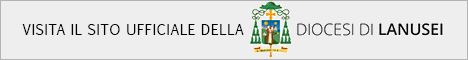

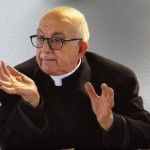





.png)