di Fabiana, Francesca e Matteo
IV Rondine, Lanusei.
Non basta piangere una vita spezzata, non basta commuoversi su una bara. Bisogna parlare, trovare il coraggio di rompere questo silenzio soffocante.
Ci sono tragedie che non dovrebbero mai accadere. Eppure accadono, anche nella nostra terra. È successo a Marco Mameli, un ragazzo di ventidue anni che aveva ancora tutta la vita davanti, strappato agli amici e alla famiglia in una notte che per tutti sarebbe dovuta essere una festa, ma che purtroppo è finita in tragedia.
La sua storia non è solo un fatto di cronaca: è il risultato di una società malata, che affonda le radici in una mentalità chiusa, che in certi luoghi come il nostro fa fatica a cambiare, in un luogo in cui la bellezza della terra si scontra con un pensiero sbagliato, dove la violenza è ancora una presenza silenziosa, quasi accettata, come se fosse parte dell’identità della nostra società. E così i coltelli, le nostre arresoe, che dovrebbero essere solo strumenti da lavoro, in troppi casi diventano armi, simboli di una forza dimostrata nel modo più primitivo, di un potere distorto che non perdona il minimo sgarro, come se crescere in questi paesi significasse portarsi dietro, insieme al coltello, un’idea di giustizia privata e di vendetta personale, come se il rispetto si guadagnasse con la paura e non con la dignità.
Dietro ogni gesto di violenza c’è una complicità silenziosa, fatta di chi vede e sente, ma non parla, di chi sa e sceglie di restare zitto. L’omertà è la vera arma che uccide, forse ancora più delle lame. È quella voce che dice: «Non è affar mio», «Meglio non immischiarsi», «Qui le cose si risolvono così». E mentre il silenzio cresce, crescono anche la rabbia e l’impunità. Il problema non sono tanto le feste in sé, chiaramente, ma l’atteggiamento di molti, troppi giovani, che nelle feste individuano un’occasione per alimentare i contrasti. Molti ragazzi che non avrebbero mai problemi con nessuno a volte si ritrovano in mezzo a situazioni di disagio, in giri di amici che conducono sulla cattiva strada, visto che per molti è normale pensare che alle feste ci siano risse, come una componente integrante, e molti, per la paura è di rimanere soli, si conformano al gruppo.
Il caso di Marco non è isolato, ma il risultato di un problema molto più vasto; non si parla di mafia o criminalità organizzata, ma di una diffusa cultura sbagliata che colpisce i soggetti più fragili e li spinge a dover dimostrare di essere i più forti, cultura che istiga alla violenza, distrugge il dialogo, il confronto e tutte le basilari caratteristiche di civiltà. Il tutto alimentato da normalizzazione, indifferenza, cattiva cerchia di amici, pessimo esempio in casa e impunità. Così i bravi ragazzi temono di uscire di casa e l’ignoranza continua a essere alimentata da altra ignoranza, portando le situazioni a sfociare in tragedie.
Fino a quando continueremo a restare prigionieri di questa mentalità? La verità è che ogni volta che qualcuno tace, ogni volta che una comunità sceglie l’omertà, sceglie allo stesso tempo che quella violenza sia accettabile, che chiunque potrà essere la prossima vittima. Non basta piangere una vita spezzata, non basta commuoversi su una bara. Bisogna parlare, trovare il coraggio di rompere questo silenzio soffocante. Chiunque tra noi dovrebbe guardarsi allo specchio e chiedersi che tipo di comunità vogliamo essere. Il vero onore è riuscire ad alzare la voce quando tutti tacciono, dire la verità nel momento in cui è più difficile farlo, per costruire un futuro diverso che dipende solo ed esclusivamente da ognuno di noi.






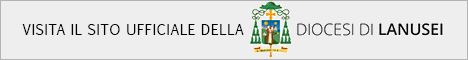


.png)



Violenza figlia di una complicità silenziosa
di Fabiana, Francesca e Matteo
IV Rondine, Lanusei.
Non basta piangere una vita spezzata, non basta commuoversi su una bara. Bisogna parlare, trovare il coraggio di rompere questo silenzio soffocante.
Ci sono tragedie che non dovrebbero mai accadere. Eppure accadono, anche nella nostra terra. È successo a Marco Mameli, un ragazzo di ventidue anni che aveva ancora tutta la vita davanti, strappato agli amici e alla famiglia in una notte che per tutti sarebbe dovuta essere una festa, ma che purtroppo è finita in tragedia.
La sua storia non è solo un fatto di cronaca: è il risultato di una società malata, che affonda le radici in una mentalità chiusa, che in certi luoghi come il nostro fa fatica a cambiare, in un luogo in cui la bellezza della terra si scontra con un pensiero sbagliato, dove la violenza è ancora una presenza silenziosa, quasi accettata, come se fosse parte dell’identità della nostra società. E così i coltelli, le nostre arresoe, che dovrebbero essere solo strumenti da lavoro, in troppi casi diventano armi, simboli di una forza dimostrata nel modo più primitivo, di un potere distorto che non perdona il minimo sgarro, come se crescere in questi paesi significasse portarsi dietro, insieme al coltello, un’idea di giustizia privata e di vendetta personale, come se il rispetto si guadagnasse con la paura e non con la dignità.
Dietro ogni gesto di violenza c’è una complicità silenziosa, fatta di chi vede e sente, ma non parla, di chi sa e sceglie di restare zitto. L’omertà è la vera arma che uccide, forse ancora più delle lame. È quella voce che dice: «Non è affar mio», «Meglio non immischiarsi», «Qui le cose si risolvono così». E mentre il silenzio cresce, crescono anche la rabbia e l’impunità. Il problema non sono tanto le feste in sé, chiaramente, ma l’atteggiamento di molti, troppi giovani, che nelle feste individuano un’occasione per alimentare i contrasti. Molti ragazzi che non avrebbero mai problemi con nessuno a volte si ritrovano in mezzo a situazioni di disagio, in giri di amici che conducono sulla cattiva strada, visto che per molti è normale pensare che alle feste ci siano risse, come una componente integrante, e molti, per la paura è di rimanere soli, si conformano al gruppo.
Il caso di Marco non è isolato, ma il risultato di un problema molto più vasto; non si parla di mafia o criminalità organizzata, ma di una diffusa cultura sbagliata che colpisce i soggetti più fragili e li spinge a dover dimostrare di essere i più forti, cultura che istiga alla violenza, distrugge il dialogo, il confronto e tutte le basilari caratteristiche di civiltà. Il tutto alimentato da normalizzazione, indifferenza, cattiva cerchia di amici, pessimo esempio in casa e impunità. Così i bravi ragazzi temono di uscire di casa e l’ignoranza continua a essere alimentata da altra ignoranza, portando le situazioni a sfociare in tragedie.
Fino a quando continueremo a restare prigionieri di questa mentalità? La verità è che ogni volta che qualcuno tace, ogni volta che una comunità sceglie l’omertà, sceglie allo stesso tempo che quella violenza sia accettabile, che chiunque potrà essere la prossima vittima. Non basta piangere una vita spezzata, non basta commuoversi su una bara. Bisogna parlare, trovare il coraggio di rompere questo silenzio soffocante. Chiunque tra noi dovrebbe guardarsi allo specchio e chiedersi che tipo di comunità vogliamo essere. Il vero onore è riuscire ad alzare la voce quando tutti tacciono, dire la verità nel momento in cui è più difficile farlo, per costruire un futuro diverso che dipende solo ed esclusivamente da ognuno di noi.