8 minuti e 26 secondi

di Claudia Carta.
Io non so chi fosse davvero George Floyd.
Non so se davvero con banconote false abbia acquistato sigarette vere. Non so perché nel suo recente passato abbia scelto, arma in pugno,di vestire i panni del rapinatore. Panni pesanti quanto i cinque anni di galera: la sua condanna.
So che George Floyd era uomo. Mi basta.
Uno sportivo. Un atleta. Spalle larghe. Braccia forti. Gianna, la sua bambina di 6 anni, e Quincy di 22, sono i suoi trofei più preziosi, i più cari, i più grandi.
George Floyd era un padre. Un marito. Il Covid-19 non ha risparmiato nemmeno lui. Positivo. Ma prima ancora gli ha portato via il lavoro: addetto alla sicurezza in un ristorante. Chiuso.
Un uomo. Nero. È importante? No. Non dovrebbe esserlo. Eppure a Minneapolis, la città dell’acqua, dei laghi e del grano, se sei nero o bianco la differenza c’è. Qui la polizia viene accusata di razzismo e uso eccessivo della forza, specie dai residenti afroamericani: 20% della popolazione della città, ma hanno maggiori probabilità di essere fermati, arrestati e maltrattati rispetto ai residenti bianchi. Oltre il 60% delle vittime nelle sparatorie con le Forze dell’ordine negli ultimi 10 anni sono neri.
A Minneapolis la pelle fa la differenza. Ed è pesante. Come il corpo di George Floyd, riverso a terra. Cade. Grande. Forte. Energico. Ma è a terra. Il cuore è debole.
Otto minuti. Claustrofobia. Timore ossessivo di trovarsi in ambienti chiusi. George lo è. Dentro la macchina non riesce a stare, anche se è quella della polizia. Sette minuti. Sono in due, poi in tre, poi in quattro. Sei minuti. È una manovra che ti insegnano a scuola: ginocchio sul collo per bloccare chiunque ti capiti sotto tiro. E un bravo agente la conosce bene. Cinque minuti. Premi forte. Blocca i movimenti. Smorza le reazioni. Schiaccia ogni resistenza. Quattro minuti. La mano in tasca. Come a premere di più. Come di chi aspetta. Ancora. Perché ancora non basta. Tre minuti. La gente intorno. I video. Lo sgomento. Lo sdegno. Manca l’aria. Due minuti. La vita si aggrappa negli occhi che cercano ossigeno, su quelle labbra bagnate di cemento freddo. Un minuto. Il respiro. Quell’alito che anima il corpo nel bene e nel male e che ti spalanca la porta dei giorni e della storia. Dov’è? Non c’è. 46 secondi. Aria. Aria. Aria. La preghiera: «Amico, non riesco a respirare, lasciami…».
La voce di Gianna, il suo sorriso e i suoi baci. Il canestro più bello a basket. Il primo giorno di lavoro. La partita di football… Buio.
In piedi, signori, davanti a un uomo che implorava solo un soffio di fiato.

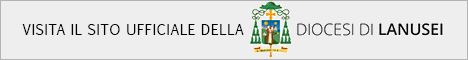







.png)



Lascia un Commento