di Tonino Loddo
Si sorprende perfino, quando gli chiedo se va ai funerali. Certu ca andu, soi sempri andau a tottu is interrusu. Così, come a dire:ma che razza di domande mi fa se la risposta è ovvia ed univoca! Arturo Olianas, 91 anni, una vita tra i boschi della sua Esterzili a inseguire il gregge, svicola subito, vorrebbe narrarmi altre storie, non quella scontata delle sue partecipazioni ai funerali. A tutti i funerali del suo paese. È arrivato con addosso una camicia di bucato. Dritto e forte come le querce del Gennargentu. Appare sorpreso della domanda. È raru chi unu no andidi a su mortu, po interrai. Est’unu doveri. Non d’appu mai mancau unu. Eccetto quei due anni che era emigrato in Germania. Ma non aveva resistito al richiamo dei suoi bambini e delle foreste. Candu mi erribbanta is litterasa cun is disegneddus de is pipius istau mali. Tace un momento, come a soffocare un’emozione che si rinnova. I dd’iscidi ca mi ponia peri a prangiri? Così tornò in paese. E quando si diffondeva la voce di un paesano morto, lasciava il suo gregge e scendeva dal monte, a toccai sa manu. Mi guarda. Abbiamo finito? No; voglio che mi racconti, com’era il funerale quando era bambino, cos’è cambiato nel tempo …
Una orta… Sì, una volta i funerali non erano come adesso. Fuiaus poberus. Erribada su maist’e linna cun d’una parigh’e taulasa e fattu su baulu. Ricorda quel povero morto che era così povero che dovettero sconnettere delle tavole da su intaulau per potergli costruire addosso una bara. Ma era una famiglia numerosa, dice; non poteva spendere nulla per il funerale. E un moto di dispiacere gli fa storcere le labbra. Ma era stato un caso davvero insolito. Perché tutti, arrivati ad una certa età, cominciavano a mettere da parte su inai po interrai, ed anche su estiri de interrai. Perché la morte aveva la sua dignità. Anche la sua era una famiglia povera, divaga. Ricorda benissimo quella volta che sua mamma dovette tagliare un lenzuolo del corredo di sposa per potergli fare un paio di pantaloni. Tandu fud’aici: priogu e famini.
Ma subito zio Arturo si riprende, accodiada su jinau po ddu estire. Si, c’era tutto il vicinato a sostenere il dolore dei parenti, nessuno si tirava indietro. Il dolore andava consolato subito. Bisognava stare accanto a chi soffriva. E intorno ai letti di morte si acquietavano i dissapori e perfino si ricomponevano vecchie liti familiari che, sì, potevano anche riprendere in seguito, ma in quei momenti tragici e supremi bisognava farle tacere per rispetto al morto e per un affettuoso rispetto verso i familiari. E poi, aggiunge, perché litigare tra parenti? Po sa cosa? Fa una smorfia. Tantu non ddi liaus nudda!
I ricordi affiorano, finalmente. Is ominisi abarriaus in forasa e is feminas aube fu su mortu, e atitanta. Si ferma ancora. Atitài. Il suono di questo verbo straordinario mi colpisce. Non erano prefiche prezzolate a improvvisare canti funebri; erano le donne di casa, mogli madri sorelle figlie, a piangere in versi il proprio struggente dolore, quasi gridandolo al mondo. Un verbo che richiama (tita) la maternità: il canto funebre si trasmutava in una sorta di allattamento simbolico, quasi un ultimo accompagnamento oltre la porta buia, e il morto, tornato bambino indifeso, veniva simbolicamente accostato al seno per dargli ancora conforto e sicurezza. In quelle case buie e povere faceva capolino una tenerezza inconsueta e dolcissima. Tutti ascoltavano in silenzio. Non pochi piangevano, anche se furtivamente, quasi a nascondere pudicamente una debolezza.
Ricorda qualche funerale in particolare? Nossi. E mi spiega che i funerali sono tutti uguali, perché dinanzi alla morte non ci sono poveri né ricchi, ma uomini e donne che hanno finito un viaggio. Poiti ca de terra seu e a terra app’a torrai. Est’aici, es propriu aici, mormora, scuotendo lievemente la testa. Si avverte nell’andare delle parole il pregio di una saggezza antica che suona inusuale nel contesto contemporaneo di una cultura che in tanti modi tende a censurare l’esperienza del morire e crea barriere di noncuranza dinanzi all’innata paura della fine. Zio Arturo guarda alla morte con realismo e saggezza, invitando a coglierne e a viverne anche la novità inattesa che la fede cristiana sprigiona nella realtà della stessa morte. E ricorda il canto del rosario al lume fioco delle candele, in quel sardo che era semplice e possente a un tempo. Gli uomini, quando le donne alzavano alto e commosso quel canto, tacevano. E se non vi partecipavano con le labbra, vi partecipavano certo col cuore. Immoi e in s’ora de sa nostra morte… Poite ca sa morte erriba po tottus.
Gli occhi di zio Arturo si illuminano quando parla delle corbule che sul far della notte si muovevano leggere dalle case vicine per raggiungere la casa del lutto. Is de jinau ddis portanta cos’e pappai. In quelle ceste vi erano le vivande che ciascuno poteva offrire, un po’ di pane, del formaggio, latte appena munto, carne arrosto, qualche verdura… Prodotti della terra e del lavoro che tutti, più o meno, possedevano, in una gara di affettuosa solidarietà. Perché, spiega, quando muore uno in casa, il dolore prende il sopravvento e per molti giorni non si ha neppure voglia di preparare di che mangiare. E a tutto suppliva il buon cuore del vicinato.
Insomma, la morte come momento immancabile dell’esistenza, come momento profondamente umano. Perciò, quando iniziava novembre la memoria dei morti si trasformava in una vera e propria festa, cui tutti i bambini prendeva parte attivamente andando in giro per il paese a chiedere a is animas. Era la festa de Su Prugadoriu. Si preparava il pan’e saba e la notte del 1 novembre a mezzanotte tutti partecipavano alla messa solenne in suffragio delle anime dei morti del paese. Ed è ancora bambino, zio Arturo, mentre insieme a tutti gli altri bambini, armato di matracula, va in giro per il paese ad annunciare l’ora di inizio della messa. Tre giri di strepito. Al secondo la gente comincia ad uscir di casa e si dirige verso l’antica parrocchiale in fondo al paese. Immoi e in s’ora de sa nostra morte …






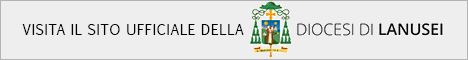


.png)



Ma a morire deve essere la solitudine
di Tonino Loddo
Si sorprende perfino, quando gli chiedo se va ai funerali. Certu ca andu, soi sempri andau a tottu is interrusu. Così, come a dire:ma che razza di domande mi fa se la risposta è ovvia ed univoca! Arturo Olianas, 91 anni, una vita tra i boschi della sua Esterzili a inseguire il gregge, svicola subito, vorrebbe narrarmi altre storie, non quella scontata delle sue partecipazioni ai funerali. A tutti i funerali del suo paese. È arrivato con addosso una camicia di bucato. Dritto e forte come le querce del Gennargentu. Appare sorpreso della domanda. È raru chi unu no andidi a su mortu, po interrai. Est’unu doveri. Non d’appu mai mancau unu. Eccetto quei due anni che era emigrato in Germania. Ma non aveva resistito al richiamo dei suoi bambini e delle foreste. Candu mi erribbanta is litterasa cun is disegneddus de is pipius istau mali. Tace un momento, come a soffocare un’emozione che si rinnova. I dd’iscidi ca mi ponia peri a prangiri? Così tornò in paese. E quando si diffondeva la voce di un paesano morto, lasciava il suo gregge e scendeva dal monte, a toccai sa manu. Mi guarda. Abbiamo finito? No; voglio che mi racconti, com’era il funerale quando era bambino, cos’è cambiato nel tempo …
Una orta… Sì, una volta i funerali non erano come adesso. Fuiaus poberus. Erribada su maist’e linna cun d’una parigh’e taulasa e fattu su baulu. Ricorda quel povero morto che era così povero che dovettero sconnettere delle tavole da su intaulau per potergli costruire addosso una bara. Ma era una famiglia numerosa, dice; non poteva spendere nulla per il funerale. E un moto di dispiacere gli fa storcere le labbra. Ma era stato un caso davvero insolito. Perché tutti, arrivati ad una certa età, cominciavano a mettere da parte su inai po interrai, ed anche su estiri de interrai. Perché la morte aveva la sua dignità. Anche la sua era una famiglia povera, divaga. Ricorda benissimo quella volta che sua mamma dovette tagliare un lenzuolo del corredo di sposa per potergli fare un paio di pantaloni. Tandu fud’aici: priogu e famini.
Ma subito zio Arturo si riprende, accodiada su jinau po ddu estire. Si, c’era tutto il vicinato a sostenere il dolore dei parenti, nessuno si tirava indietro. Il dolore andava consolato subito. Bisognava stare accanto a chi soffriva. E intorno ai letti di morte si acquietavano i dissapori e perfino si ricomponevano vecchie liti familiari che, sì, potevano anche riprendere in seguito, ma in quei momenti tragici e supremi bisognava farle tacere per rispetto al morto e per un affettuoso rispetto verso i familiari. E poi, aggiunge, perché litigare tra parenti? Po sa cosa? Fa una smorfia. Tantu non ddi liaus nudda!
I ricordi affiorano, finalmente. Is ominisi abarriaus in forasa e is feminas aube fu su mortu, e atitanta. Si ferma ancora. Atitài. Il suono di questo verbo straordinario mi colpisce. Non erano prefiche prezzolate a improvvisare canti funebri; erano le donne di casa, mogli madri sorelle figlie, a piangere in versi il proprio struggente dolore, quasi gridandolo al mondo. Un verbo che richiama (tita) la maternità: il canto funebre si trasmutava in una sorta di allattamento simbolico, quasi un ultimo accompagnamento oltre la porta buia, e il morto, tornato bambino indifeso, veniva simbolicamente accostato al seno per dargli ancora conforto e sicurezza. In quelle case buie e povere faceva capolino una tenerezza inconsueta e dolcissima. Tutti ascoltavano in silenzio. Non pochi piangevano, anche se furtivamente, quasi a nascondere pudicamente una debolezza.
Ricorda qualche funerale in particolare? Nossi. E mi spiega che i funerali sono tutti uguali, perché dinanzi alla morte non ci sono poveri né ricchi, ma uomini e donne che hanno finito un viaggio. Poiti ca de terra seu e a terra app’a torrai. Est’aici, es propriu aici, mormora, scuotendo lievemente la testa. Si avverte nell’andare delle parole il pregio di una saggezza antica che suona inusuale nel contesto contemporaneo di una cultura che in tanti modi tende a censurare l’esperienza del morire e crea barriere di noncuranza dinanzi all’innata paura della fine. Zio Arturo guarda alla morte con realismo e saggezza, invitando a coglierne e a viverne anche la novità inattesa che la fede cristiana sprigiona nella realtà della stessa morte. E ricorda il canto del rosario al lume fioco delle candele, in quel sardo che era semplice e possente a un tempo. Gli uomini, quando le donne alzavano alto e commosso quel canto, tacevano. E se non vi partecipavano con le labbra, vi partecipavano certo col cuore. Immoi e in s’ora de sa nostra morte… Poite ca sa morte erriba po tottus.
Gli occhi di zio Arturo si illuminano quando parla delle corbule che sul far della notte si muovevano leggere dalle case vicine per raggiungere la casa del lutto. Is de jinau ddis portanta cos’e pappai. In quelle ceste vi erano le vivande che ciascuno poteva offrire, un po’ di pane, del formaggio, latte appena munto, carne arrosto, qualche verdura… Prodotti della terra e del lavoro che tutti, più o meno, possedevano, in una gara di affettuosa solidarietà. Perché, spiega, quando muore uno in casa, il dolore prende il sopravvento e per molti giorni non si ha neppure voglia di preparare di che mangiare. E a tutto suppliva il buon cuore del vicinato.
Insomma, la morte come momento immancabile dell’esistenza, come momento profondamente umano. Perciò, quando iniziava novembre la memoria dei morti si trasformava in una vera e propria festa, cui tutti i bambini prendeva parte attivamente andando in giro per il paese a chiedere a is animas. Era la festa de Su Prugadoriu. Si preparava il pan’e saba e la notte del 1 novembre a mezzanotte tutti partecipavano alla messa solenne in suffragio delle anime dei morti del paese. Ed è ancora bambino, zio Arturo, mentre insieme a tutti gli altri bambini, armato di matracula, va in giro per il paese ad annunciare l’ora di inizio della messa. Tre giri di strepito. Al secondo la gente comincia ad uscir di casa e si dirige verso l’antica parrocchiale in fondo al paese. Immoi e in s’ora de sa nostra morte …